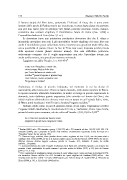Page 136 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 136
124 Giuseppe Gilberto Biondi
il famoso incipit del libro terzo, contenente l’‘odissea’ di Enea, che si pone come
ipotesto delle parole di Ecuba proprio per la pericope et omnis humo fumat che pertanto
non può non essere fons di omnisque late fumat, pericope senecana. Ecuba, dunque,
contamina due contesti virgiliani, il trionfalistico futuro di Roma (Aen. 1,284) e
l’apocalittica halosis di Troia (Aen. 3,1 ss.).
Se dovessimo trarre una primissima conclusione dovremmo dire che S. riduce a
inesorabile apocalisse non solo il già apocalittico incipit virgiliano del terzo libro ma
anche il trionfalistico passo sulla futura Roma: insomma una apocalisse totale della città,
senza possibilità di parusie future: la fine di Troia tout-court, disperata perché privata
della speranza romana (fumat Assaraci domus). Una cosa addirittura potremmo
audacemente avanzare: che S. voglia rappresentare non solo l’apocalisse troiana, ma
anche quella romana, una apocalisse insomma universale.
9
Leggiamo ora, delle Troades, i vv. 469-474:
o nate sero Phrygibus, o matri cito,
eritne tempus illud ac felix dies
quo Troici defensor et vindex soli
10
recidiva ponas Pergama et sparsos fuga
cives reducas, nomen et patriae sum
Phrygibusque reddas?
Andromaca si rivolge al piccolo Astianatte, nel momento in cui ha deciso di
nasconderlo, alla ricerca che i Greci ne stanno facendo, nello stesso sepolcro di Ettore.
In questo momento altamente drammatico, la madre si rivolge al piccolo esprimendo la
domanda, tanto dubbiosa quanto angosciosa (che coincide col timore dei Greci, che
infatti vogliono eliminarlo) se dovesse venir mai un tempo in cui l’attuale figlio, vinto,
11
di Ettore potrà vendicare i vinti Troiani e fondare Pergamo recidiva.
Notiamo subito come, al pari di Assaraci domus, di cui sopra, l’espressione recidiva
Pergama indichi, idealmente, la ricostruzione di Troia, e, ‘realmente’, Roma. Essa ricorre,
12
prima del nostro passo senecano, solo tre volte nell’Eneide: 7,322; 10,58 e 4,344
me si fata meis paterentur ducere vitam
auspiciis et sponte mea componere curas,
9
Keulen (2001) ad v. 470 rimanda a georg. 1,276-277; ad v. 471 rimanda ad Aen. 12,547; 2,521-522. Cfr.
Schiesaro (2003), che a proposito di questi versi afferma: «Andromache repeatedly voices her hope of a
“Vergilian” future for her son» (p. 195).
10 L’Etruscus legge rediviva, come peraltro alcuni codici virgiliani ad Aen. 10,58, uno dei passi citati a
confronto (cfr. Conte [2009], ad loc.); la lezione sembra essere accolta da Paratore (1978-1983), che ad loc.
afferma «Seneca doveva leggere rediviva, perché in Troades 472, imitando il passo, ha scritto
rediviva…Pergama».
11 La preconizzazione che nelle Troades Andromaca fa al figlio (vv. 470-474) riguardo a un impero che
presenta i tratti caratteristici di quello romano è già stata notata da Walter (1975, p. 12) (cito da Corsaro
[1991 p. 91, n. 77]).
12 Fra i commentatori virgiliani la ripresa senecana di quest’ultimo passo è stata osservata da Forbiger (1875),
che rimanda a Gronov. ad Sen. Tro. 472. Per tutti e tre i passi virgiliani cfr. Fantham (1982) ad loc. – che
rimanda anche ad Aen. 12,828 – e Keulen (2001) ad loc.; per l’ultimo locus cfr. Lawall (1982, p. 245) (cito da
Zissos [2008, p. 193, n. 5]) e Boyle (1994) ad loc.