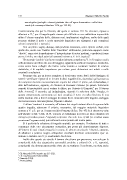Page 134 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 134
122 Giuseppe Gilberto Biondi
monologiche (prologhi e rheseis) piuttosto che nell’agone drammatico e nella lirica
corale (cfr. comunque Marchesi 1976, pp. 182-85).
Contrariamente che per S. filosofo, del quale si contano 118 fra citazioni, riprese e
1
allusioni a V., per il tragediografo rimane più difficile se non addirittura impossibile
stilare l’elenco completo delle, diciamo così, implicazioni virgiliane, molte delle quali
possono eludere il nudo e crudo materiale linguistico per allargarsi a più complessi
schemi compositivi e narrativi.
Con un primo vaglio, dunque, sarà prudente setacciare, come riprese verbali, solo
quelle che, anche con l’ausilio delle ‘macchine’ elettroniche, potremmo supporre come
‘dirette’, senza cioè la mediazione o l’interpolazione di autori mediani, o mediatori (come
2
per es. Ovidio, uno degli autori più presenti insieme a V. in S. tragico).
Un secondo ‘cerchio’ (un lavoro tendenzialmente completo su V. in S. tragico va più
nella direzione del libro che non del saggio), riguarda la scelta dei campioni, scelta che,
come sanno bene colleghi che hanno come metodo e contenuti risultati di scienze
statistiche, è di capitale importanza per evitare gravi distorsioni nei referti e nelle
eventuali conclusioni.
Premesso che, per un lavoro completo, si dovrà tener conto, fatti i debiti distinguo, di
tutte le ‘certificate’ riprese di V. in tutte le dieci tragedie di S., dovendosi qui lavorare su
dei campioni dovremo necessariamente seguire dei criteri: il primo, ad excludendum, è
dato dall’esclusione, appunto, di Octavia ed Hercules Oetaeus (in quanto fortemente
3
sospetti di inautenticità: ma si vedano le difese, per Octavia di Giancotti, per l’Oetaeus
4
della Averna); il secondo, ad includendum, riguarda la selezione delle Troades, in
quanto estremamente consonante coi temi eneadici; il terzo va nella direzione di una
scelta random, vale a dire il sorteggio di alcune fra le rimanenti sette tragedie, sorteggio
che ha interessato Hercules furens, Thyestes e Medea.
L’ultima ‘rasatura’ è avvenuta, all’interno dei singoli sistemi allusi di ognuna delle
quattro tragedie, attraverso il criterio, meccanico, del maggior materiale linguistico
comune a V. e S.: per es. il nesso recidiva Pergama di Sen. Tro. 472 lo si ritrova tre volte
nell’Eneide: 4,344; 7,322; 10,58. Tuttavia se estendiamo la ricerca al terzo elemento del
sintagma (recidiva ponas Pergama) scopriamo che solo Aen. 4,344 (et recidiva manu
posuissem Pergama victis) può collocarsi come ipotesto del nostro passo.
Si è preferita la selezione di tragedie anziché, per esempio, l’inclusione di tutte o
comunque delle otto sicuramente autentiche, per poter più sinteticamente disporre,
all’interno di ogni singola tragedia in esame, di almeno un piccolo ‘sistema’, appunto,
di allusioni e poterne meglio estrapolare eventuali direzioni ermeneutiche (per es.
sintonie o distonie con V.) e confrontarle tra di loro.
Inutile dire quanto sia viscido il terreno che stiamo per percorrere, non solo per la
complessità delle due gigantesche personalità poetiche e culturali (V. e S., appunto),
complessità che diventa esponenziale visto che ne trattiamo il confronto, ma vista anche
1 Cfr. Mazzoli (1970, in partic. pp. 215-232).
2 Cfr. Degl’Innocenti Pierini (2008).
3 Giancotti (1954).
4
Averna (2002).