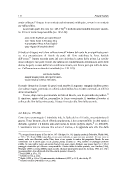Page 124 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 124
112 Eckard Lefèvre
errato collocare l’Oetaeus in un contesto esclusivamente mitologico, ovvero in un contesto
per nulla politico.
70
La seconda parte del coro (vv. 143-172) è dedicata alla brutalità di Ercole vincito-
re. Inizia in modo inequivocabile (vv. 143-146):
quae cautes Scythiae, quis genuit lapis?
num Titana ferum te Rhodope tulit,
te praeruptus Athos, te fera Caspia?
quae virgata tibi praebuit ubera?
Si tratta sì di topoi, ma la loro collocazione all’interno del canto ha un significato preci-
so. «La presentazione di Ercole da parte del Coro sottolinea la forza bestiale
71
dell’eroe». Questa seconda parte del coro chiarisce le cause della prima. La conclu-
sione collega le due parti: Ercole che infuria nel combattimento determina la sorte delle
donne, le quali, a causa della loro condizione misera, non hanno però più nulla da teme-
re. L’affermazione su Ercole è micidiale (vv. 170-172):
commoda cladibus
magnis magna patent, nil superest mali –
iratum miserae vidimus Herculem.
Secondo Gronovius il senso di questi versi sarebbe il seguente: «magnis cladibus patere
sive adesse magna commoda: ex ultimis calamitatibus hoc existere commodi, ut nihil sit
72
ultra metuendum».
73
Il coro, dopo avere sperimentato la furia di Ercole, non ha più nulla da perdere.
Il vincitore, spinto dall’ira, personifica la forza eccezionale. Il tumidus Hercules si
colloca alla fine della prima parte, l’iratus Hercules alla fine della seconda.
2.4. Iole (vv. 173-224)
Come terzo personaggio è introdotta Iole, la figlia del re di Ecalia, ora prigioniera di
guerra. Il suo lamento, che si effonde ampiamente, è ben comprensibile: la città natale è
74
distrutta, i genitori e il fratello sono stati uccisi da Ercole (letifero stipite, vv. 208-209).
L’ascoltatore non ne conosce fino ad ora il motivo, e lo apprende solo alla fine della
70 La trasposizione da parte di Leo dei vv. 147-150 dopo il v. 142 (seguita anche da Zwierlein, Walde 1992,
p. 112 n. 72 e Rossi 2000) è superflua, se non poco calzante, in ogni caso non provabile. Al coro viene in
mente, nelle sue riflessioni, anche Tebe, dove si era sposata la madre del prepotente Ercole. Se esso
continuasse con le parole falsa est de geminis fabula noctibus (v. 147), sarebbe un passaggio piuttosto
scialbo. Se esso replica invece ad vocem Herculis con quae cautes Scythiae, quis genuit lapis? (v. 143), il
passaggio riuscirebbe più efficace e comprensibile. Il testo tràdito dovrebbe pertanto, con Giardina (1966),
Thomann (1969) e Averna (2002), essere accolto. (Il punto interrogativo posto da Axelson, 1967, al v. 142 è
incomprensibile: dove altrimenti dovrebbe essersi sposata Alcmena?).
71 Rossi (2000, p. 67 n. 35).
72 Schröder (1728, p. 628).
73 Walde (1990, p. 114 n. 81), misconosciuto da Marcucci (1997, p. 114), che cita Ag. 97.
74
«Clava Herculis» (Farnabius 1676, p. 284).