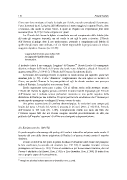Page 122 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 122
110 Eckard Lefèvre
Giove non deve mostrare a Ercole la strada per il cielo, ma solo concedergli il permesso:
l’eroe la troverà da sé. La hybris dell’affermazione è tanto maggiore in quanto Ercole, oltre
a Giunone, cita anche lo stesso Giove, il quale in Virgilio usa l’espressione fata viam
invenient (Aen. 10,113): Ercole compete con i fata!
Per l’Ercole del Furens la hybris si manifesta non nel compimento delle fatiche (che
del resto gli vengono imposte), ma nel modo in cui egli le porta a termine. L’Ercole
dell’Oetaeus si spinge oltre il suo predecessore, portando a compimento più fatiche di
quelle che gli erano state ordinate, e di ciò ritiene responsabile la propria natura in misura
maggiore rispetto a Giunone (vv. 61-63):
o quanta fudi monstra quae nullus mihi
rex imperavit! institit virtus mihi
Iunone peior.
65
A incitarlo è stato il suo coraggio, ‘peggiore’ di Giunone. Questo Ercole è il conseguente
ulteriore sviluppo dell’Ercole del Furens che tende verso la hybris e chiede di fare più di
quanto possa (Herc. f. 614-615). L’Ercole dell’Oetaeus fa realmente di più.
Al termine del monologo Ercole si esprime in modo ancora più esplicito: quem tuli
mundum peto (v. 98). L’eroe ‘dimentica’ completamente che non agisce su incarico di
Giove, ma perché Giunone lo ha perseguitato ed egli ha dovuto scontare una pena per
ordine di Euristeo. La sua hybris non conosce limiti.
Ercole argomenta come pare e piace. Ciò si riflette anche nella struttura: mentre
l’Ercole del Furens ha appena portato a termine le dodici fatiche impostegli, per l’Ercole
dell’Oetaeus non è indicato nessun particolare momento se non quello negativo della
distruzione di Ecalia per sua iniziativa. Di qui si può trarre la conclusione che l’Oetaeus per
questo aspetto presuppone e sviluppa il Furens, ovvero lo varia.
Una prima osservazione di carattere drammaturgico: le variazioni sono sempre più
lunghe del tema. L’Ercole del Furens si presenta in 26 versi (Herc. f. 592-617), l’Ercole
dell’Oetaeus in 103 versi (vv. 1-103). L’ampliamento risulta non tanto dal fatto che
l’Oetaeus espone fatti che nel Furens vengono ricordati precedentemente da altri, ma
piuttosto dall’impulso ‘egomane’ di offrire una straripante autopresentazione.
2.3. Il primo coro (vv. 104-172)
Il quadro negativo che emerge dal prologo di Ercole si intensifica nel primo canto corale. Il
lamento del coro delle donne prigioniere di Ecalia è un’accusa vivente contro il superbo
vincitore.
Il canto si divide in due parti: la prima focalizza l’attenzione sulle donne che piangono
la loro condizione, la seconda sul vincitore (vv. 142-172). Il tumidus Hercules si trova
pressappoco nel mezzo (v. 142). L’eroe si caratterizza per la sua natura tirannica, che nel
Furens è attribuita a lui (tumet, Herc. f. 68) e a Lico (tumidus, Herc. f. 384). Si tratta di un
vero e proprio segno di riconoscimento.
65
«Magis me ad ardua incitans quam Juno» (Farnabius 1676, p. 280).