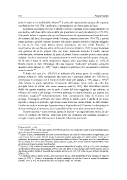Page 114 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 114
102 Eckard Lefèvre
22
porre le mani su un inafferrabile futuro». Il corso del ragionamento giunge alla seguente
conclusione (vv. 162-178): i ǠǓǕǦǞǓǖǙǓ e i ǠǓǕǙǡǛʎǖNjǞǙǓ non fanno parte dei laeti.
La sezione successiva del coro è riferita a Ercole e analizza il suo comportamento e il
suo destino, sulla base della visione della vita presentata nei versi precedenti (vv. 179-191).
Già questo induce a supporre che qui sia Seneca stesso ad argomentare per bocca del coro.
Al contrario dei laeti, che tengono stretto il tempo, tempora tenent (vv. 176-177), e quindi
sanno goderne, gli altri corrono incontro alla morte, proprio perché si lasciano sfuggire
la vita tra le dita, come Seneca spesso stigmatizza nei suoi scritti filosofici. È
significativo che qui Seneca abbia utilizzato il termine fertur (v. 183): la gens hominum
non governa da sé la propria vita, ma viene trascinata secondo il motto: ducunt
volentem fata, nolentem trahunt. Al posto di fertur l’autore avrebbe potuto usare anche
trahitur. Ercole è annoverato fra queste persone in modo tanto geniale quanto ricercato.
Se di esse è detto in senso metaforico: Stygias ultro quaerimus undas (v. 185), di
Ercole invece si dice riferendosi alla sua impresa ‘realmente’ avvenuta: properas
23
maestos visere Manes (v. 187). Egli è dunque il ǠǓǕǦǞǓǖǙǜ che vacuamente si affretta
24
verso la morte.
Il finale del coro (vv. 192-201) si riallaccia alla prima parte: la sordida parvae
fortuna domus (v. 200) corrisponde alla laeta suo / parvoque domus (vv. 160-161) e
25
viene posta in contrasto con il modo di vivere degli altri (alium, v. 192; alius, v. 195).
Alla schiera di questi appartiene l’esponente dell’audace forza virile, che alla fine
precipita verso la rovina: alte virtus animosa cadit (v. 201). Non dovrebbero esservi
dubbi che questa massima, con la quale il canto del coro raggiunge il suo culmine, si
riferisca ad Ercole e che dunque il termine animosa, in origine neutrale, qui assuma una
26
sfumatura negativa. Indipendentemente dalle considerazioni fatte da Giunone nel
prologo, l’immagine di Ercole che viene offerta in questo canto è quella di un uomo
superbo e dunque in pericolo, egli stesso causa della sua rovina futura. In altri termini:
Ercole non cade in rovina per la presunzione o la piccolezza di Giunone. La dea spiega in
chiave mitologica un processo, la cui causalità risiede su un piano puramente umano.
Il canto esprime – come avviene spesso in Seneca – un ragionamento stoico ed epi-
cureo. È evidente che Seneca, sulla base della sua vicinanza alle massime oraziane, a
cui egli si ispira anche altrove, lasci trasparire riflessioni personali.
22 Grisoli (1971, p. 83).
23
Cfr. Grisoli (1971, p. 86): «per questo verso Ercole pare al coro comportarsi come la gens hominum ignara
di sé, ed è questa una grave riserva».
24 Laetus è usato correntemente nel canto come termine per un modo di vivere sereno ed equilibrato, così
come Orazio dice in carm. 2,16,25: laetus in praesens animus quod ultra est / oderit curare. Anche qui il
godimento del presente è contrapposto all’aspirazione diretta al futuro. Con questo non è in contraddizione
che in Seneca al v. 42 si dica di Ercole: laetus imperia excipit, dove la sua maniera imperturbabile viene
caratterizzata in una locuzione non filosofica.
25 Pigros (v. 198) è inteso in senso positivo: «persone tranquille» (Caviglia, 1979, p. 111); «Die Geruhigen
und Sorglosen leben lang» (Kapnukajas, 1930, p. 22). Cfr. Med. 331 sua quisque piger litora tangens, dove il
significato positivo risulta di necessità dal contesto del brano vv. 329-334: «Otio & pace fretus» (Farnabius,
1676, p. 13).
26 «L’animosa virtus è quindi nemica, nella sua ansia d’azione, della tranquillità di vita; incapace di tempora
tenere [v. 177] […]. Essa è la negazione di quella condizione di vita che il coro si augura di realizzare»
(Bertoli, 1977, p. 91). Per la posizione del coro vengono citati i vv. 196-200.