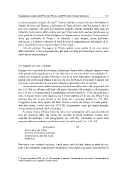Page 113 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 113
Il significato politico dell’Hercules Furens e dell’Hercules Oetaeus di Seneca 101
21
ra autonomamente rispetto alla dea. Giunone adempie la stessa funzione dell’umbra di
Tantalo all’inizio del Thyestes e dell’umbra di Tieste all’inizio dell’Agamemnon. Non si
può certo sostenere che nelle due rispettive tragedie, tasselli costitutivi della saga dei
Tantalidi, la tracotanza abbia origine solo per l’intervento delle umbrae, poiché esse ne
sono piuttosto il simbolo. Infatti la hybris di Agamennone si rivela già a Troia, quella di
Atreo già nell’esilio di Tieste – in entrambi i casi, dunque, prima dell’inizio
dell’azione. Le umbrae collocano di volta in volta il comportamento individuale di A-
treo e Agamennone tra le imprese degne di tale stirpe.
Già nel prologo l’immagine di Ercole appare come quella di un eroe spinto
dall’eccitazione, il cui comportamento, dal punto di vista dell’osservatore stoico, deve
essere inteso negativamente.
1.3. Il primo coro (vv. 125-204)
Il primo coro è un brano di letteratura. Nonostante Seneca abbia utilizzato anapesti come
nella parodo della tragedia greca, il solo fatto che essi non presentino versi catalettici di-
mostra che si tratta di un testo filosofico e non di un testo drammatico. Analogamente il
lamento dei vecchi sugli affanni della loro età, che nell’Eracle di Euripide è ispirato alla
vita reale, è qui sostituito da una ampia riflessione ideologica sulla vita umana.
Il coro prende spunto dalla descrizione del declinare della notte e del sorgere del sole
(vv. 125-136) per riflettere sull’inizio del giorno lavorativo del contadino e del pescatore
(vv. 137-161). Di questi ultimi è caratteristico un labor durus (v. 137), che però non è
visto in nessun modo come negativo, ma è invece espressione di una vita felice; è una
innocua vita, che si può trovare in una laeta suo / parvoque domus (vv. 159-161).
L’aggettivo laetus viene ripreso più tardi, riferito a coloro che vivono ‘in modo giusto’:
dum fata sinunt, / vivite laeti (vv. 177-178). Serenamente, come gli uomini descritti,
vivono anche gli animali che li circondano.
A questa visione idilliaca della vita felice sono contrapposti nella seconda parte del
coro gli esponenti della vita vacua, che secondo la buona tradizione romana sono
costituiti dai ǠǓǕǦǞǓǖǙǓ e dai ǠǓǕǙǡǛʎǖNjǞǙǓ (vv. 162-191). All’interno di questi versi
vengono citati per contrasto i pochi che vivono ‘in modo giusto’ (vv. 174-178):
novit paucos, 175
secura quies, qui velocis
memores aevi tempora numquam
reditura tenent. dum fata sinunt,
vivite laeti.
Essi «sono i rari, rarissimi sapientes, i quali sanno, unici fra tutti, attuare se stessi nel pre-
sente a loro assegnato, senza perdere vanamente le loro chances cercando, come gli altri, di
21 A torto Zwierlein (1984, pp. 15-18) paragona il rapporto Giunone-Ercole con quello Giunone-Enea in
Virgilio anziché con il rapporto Giunone-Turno.