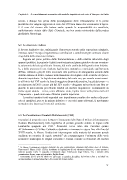Page 61 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 61
Capitolo 6 – Il consolidamento normativo del modello inquisitorio nel resto d’Europa e in Italia
secolo, e dunque ben prima della promulgazione delle Ordonnantien. E le poche
modifiche che vengono apportate al testo del 1570 non fanno che accentuarne il rigore.
È il caso del ricorso alla tortura anche quando la responsabilità sia manifesta,
esplicitamente vietato dallo Style Criminele, ma ben presto reintrodotto dalla pratica
giudiziaria fiamminga.
6.2. La situazione italiana
Il fervore legislativo che, enfatizzando l’intervento statuale nella repressione criminale,
interessa tutta l’Europa cinquecentesca contribuisce a sottolineare per contrasto alcune
singolarità della situazione italiana.
Segnata sul piano politico dalla frammentazione e dalla relativa debolezza degli
apparati pubblici, la penisola è infatti caratterizzata sul piano giuridico da una accentua-
ta autonomia del ceto giudiziario-forense, dal ruolo cardinale della produzione dottrina-
le, e dalla presenza di una risalente legislazione statutaria e municipale capillarmente
diffusa. Abbiamo già più volte accennato alla posizione di avanguardia assunta dalla
dottrina italiana di diritto comune nella fissazione dei dogmi e delle tecniche del proce-
dimento inquisitorio. La legislazione statutaria, dal canto suo, pur avendo ormai esauri-
to all’inizio del XVI secolo la fase di maggiore dinamicità creativa, ha già da tempo – e
precisamente dal XIII e ancor più dal XIV secolo – disegnato sul territorio una fitta ra-
gnatela di microsistemi procedurali fondati sul modulo inquisitorio: «communiter in
Italia vigent statuta – scrive, come abbiamo visto, Egidio Bossi nella prima metà del
Cinquecento – quod omni casu officiales possint inquirere».
I peculiari caratteri testé segnalati non impediscono peraltro che anche nella peni-
sola si manifesti, pur se in misura inferiore e con esiti meno rilevanti, il movimento
normativo che interessa il resto del continente.
6.3. Le Constitutiones Dominii Mediolanensis (1541)
Esemplari al proposito sono le Nuove Costituzioni dello Stato di Milano (Constitutiones
Dominii Mediolanensis), testo legislativo di portata generale entrato in vigore nella
1
Lombardia spagnola nel 1541. Pressoché coeve tanto alla Carolina quanto
all’Ordonnance di Villers-Cotterêts e destinate a rimanere in vigore fino alla fine del
XVIII secolo, le Nuove Costituzioni intervengono sulla materia del processo penale
2
mediante un mosaico di regole settoriali che presuppongono l’esistenza delle varie
normative municipali di origine statutaria e l’ormai comune accettazione dei moduli
1 Le Nuove Costituzioni vengono elaborate da una commissione chiamata dall’ultimo duce di Milano,
Francesco II Sforza (1521-1535) a riordinare la legislazione di età visconteo sforzesca, e sono portate a
termine quando Carlo V acquista il Milanese dopo l’estinzione degli Sforza. Tra i membri della
commissione figura, come già ricordato, Egidio Bossi.
2 Concentrate per lo più nel titolo De advocatis et syndicis fiscalibus del Primo Libro e nei titoli De
accusationibus et denuntiationibus e De poenis del Quarto Libro.
51