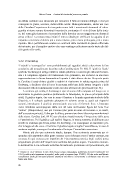Page 56 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 56
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
ma debba costituire uno strumento per conoscere il fatto nei minimi dettagli, e cioè per
conseguire la piena, assoluta, indiscutibile verità. Malauguratamente, anche nel caso
della Carolina l’esperienza ha insegnato come tutti i menzionati strumenti di salva-
guardia si siano sempre dimostrati impotenti a contrastare il vizio di base della tortu-
ra, del resto già pienamente riconosciuto dalla dottrina coeva maggiormente dotata di
4
senso critico. La tortura resta infatti il mezzo ideale per verificare la capacità di un
imputato a resistere al dolore più o meno intenso, più o meno prolungato, più o meno
ripetuto. Ma è perfettamente neutra nei confronti della veridicità di quanto affermato
da torturato, per il semplice motivo che essa costringe nello stesso modo tanto alla fal-
sità quanto alla verità.
5.2.4. Il Rechtstag
‘Teatrale’ e ‘scenografico’ sono probabilmente gli aggettivi adatti a descrivere la fase
conclusiva del procedimento descritto nella Carolina (artt. 78-103). Il ‘giudizio finale’
(entliche Rechtstag) si svolge infatti in seduta pubblica e conserva gli elaborati formali-
smi e il complesso apparato del tradizionale rito germanico, ma si risolve in una mera
rappresentazione in forma drammatica di quanto è stato altrove deciso. Su questo punto
la Carolina è assai chiara: giudici e scabini si riuniscono in seduta segreta prima del
Rechtstag, e decidono «fra di loro» la sentenza sulla base della lettura integrale e della
discussione della documentazione scritta raccolta nel fascicolo processuale (art. 81).
A sentenza già scritta, il Rechtstag si apre al suono della campana nel luogo ove si
amministra la giustizia punitiva (solitamente la Marktplatz, la piazza principale della
città). Il giudice togato, che reca in mano il bastone o la spada sguainata simbolo della
Giustizia, e il collegio scabinale giungono in solenne corteo e, assisi sui rispettivi
scranni, introducono il giudizio pronunciando una serie di formule fisse. L’imputato
viene introdotto accompagnato dalla non del tutto rassicurante figura del boia. Due
‘oratori’ (Fürsprechen), uno per l’accusa (che parla in nome del sovrano o, se esiste,
dell’accusatore privato), l’altro per la difesa, pronunciano brevi discorsi preconfezionati
dalla stessa Carolina (artt. 89-91) per chiedere rispettivamente l’irrogazione della pena
o l’assoluzione. Poi il giudice e gli scabini fingono, in buona sostanza, di deliberare per
iscritto la sentenza già decisa prima del Rechtstag, e la consegnano al cancelliere per-
ché la legga ad alta voce. Al termine il giudice togato scioglie l’assemblea e, in caso di
sentenza capitale, consegna il condannato al boia per l’immediata esecuzione.
Niente più che una cerimonia rituale, dunque. Una cerimonia conservata per ri-
spondere alle aspettative della gente comune e per deferenza verso l’antico costume, ma
svuotata di ogni sostanza per impedire che l’incompetenza tecnica degli scabini possa
pregiudicare gli esiti dell’inquisizione condotta dal giudice togato. L’autentico momen-
to deliberativo è ora collocato nella fase formalmente preliminare del procedimento, dai
4 Citiamo in via d’esempio il caso della Praxis rerum criminalium, pubblicata da Joost Damhouder nel
1554 (e sulla quale torneremo in seguito), nella quale si osserva (cap. XXXIX, 44) che sotto «sufficiente
coercizione» anche gli innocenti possono arrendersi «al dolore e al tormento e confessare cose che non
hanno mai fatto».
46