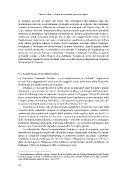Page 52 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 52
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
la massima secondo la quale «ist besser den schuldigen ledig zulassen dass den
unschuldigen zum tode zuverdampnen» («è meglio assolvere un colpevole che condannare
a morte un innocente»), affermazione ricalcata da un noto passo del Digesto (Dig., 48, 19,
5, pr.: «satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari»)
attraverso la mediazione della dottrina tardomedievale italiana, particolarmente incline a
enfatizzare siffatti consolanti principi. Ma il dato che maggiormente rileva è che la
Bambergensis rappresenta, per usare un’espressione qualificativa particolarmente diffusa
nella cultura giuridica tedesca, la Madre della Constitutio Carolina (Mater Carolinae;
ovviamente, l’Ordinanza del Brandenburg è la Soror Carolinae). Essa si propone infatti
come modello strutturale e contenutistico non solo per l’Ordinanza di Brandenburg, ma
anche per la ben più famosa e importante Constitutio Criminalis Carolina, la grande
normativa comune a tutto l’Impero che costituisce il punto di arrivo del processo di
risistemazione legislativa della disciplina della procedura penale sviluppatosi in Germania
all’inizio del XVI secolo.
5.2. La promulgazione della Carolina
1
La Constitutio Criminalis Carolina – o, più semplicemente, la Carolina – rappresenta
se non il più ragguardevole certo uno dei maggiori eventi nella storia della Recezione
del princìpi del diritto comune in Germania.
Destinata a costituire fin oltre il XVIII secolo la principale fonte del diritto penale
sostanziale e processuale nei Paesi Tedeschi, la Carolina è promulgata dall’imperatore
Carlo V d’Asburgo (che le trasmette il proprio nome) il 27 giugno 1532, a 35 anni dal
primo riconoscimento ufficiale della necessità di una legislazione penale unica per tutto
l’Impero (Dieta di Freiburg, 1497-98), e a un decennio dai primi progetti, realizzati sul-
la scorta della Bambergensis dopo la Dieta di Norimberga del 1521.
Decisiva per il felice esito di tale vicenda legislativa è l’inserzione nel testo della
Carolina della cosiddetta clausola di salvaguardia (salvatorische Clausel, clausula
salvatoria), che garantisce il rispetto delle pratiche, delle regole e degli usi locali. La
clausola consente di superare le obiezioni – connaturate al particolarismo politico tipico
della Germania tardomedievale e rinascimentale – sollevate da alcune tra le compagini
territoriali autonome (principati, vescovati, città libere, ecc.) presenti nell’Impero, ben
decise a non rinunciare alle rispettive consuetudini in materia penale.
La salvatorische Clausel consente altresì l’entrata in vigore di normative regionali
parzialmente derogatorie rispetto alla disciplina comune dettata dalla Carolina. Tra queste
spicca la Hessische Halsgerichtsordnung in peinlichen Sachen (in latino: Constitutio
Criminalis Assiaca), pubblicata nel 1535 da Filippo il Magnanimo, landgravio d’Assia, e
detta di conseguenza Philippina. Altre ordinanze complementari saranno pubblicate nel
Palatinato (1582), ad Amburgo (1603) e in Baviera (1616).
1 La denominazione ufficiale tedesca è Kayser Karls des Fünften und des Heyligen Römischen Reichs Peinlich
Gerichtsordnung. Secondo il costume germanico, la Carolina viene sovente indicata con la sigla corrispon-
dente all’intitolazione latina del testo, e cioè CCC.
42