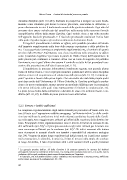Page 54 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 54
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
ratissima disciplina (artt. 181-203), destinata in prospettiva a svolgere un ruolo fonda-
mentale come strumento per fissare la nuova procedura, assicurarne la diffusione, e
porre ulteriormente in crisi il tradizionale mondo della giustizia scabinale. Ogni atto del
processo deve essere verbalizzato dal cancelliere sulla scorta delle numerose formule
esemplificative offerte dalla stessa Carolina. Ogni verbale viene a sua volta raccolto
nell’apposito fascicolo processuale. E il fascicolo processuale costituisce l’unica base
sulla quale il giudice togato e gli scabini costruiscono la decisione finale.
Di regola il procedimento è avviato ex officio, ed è possibile procedere all’arresto
dell’imputato semplicemente sulla base della comune reputazione o della pubblica fa-
ma. L’accusa privata è ammessa e ampiamente regolamentata ma, al contrario di quanto
previsto dalla Wormser Reformation, essa viene incardinata nella procedura ex officio
come ‘preambolo legittimo’ (per usare le parole di Giulio Claro) dell’inquisizione: la
parte privata può continuare a rimanere attiva con un ruolo di supporto del pubblico
funzionario, ma è quest’ultimo che assume il controllo su tutte le fasi procedurali suc-
cessive alla presentazione dell’atto di accusa (artt. 6-17).
L’inquisizione (o processo informativo) è totalmente segreta, non prevede alcuna
forma di difesa tecnica, e trova il proprio momento qualificante nell’accurata disciplina
relativa ai mezzi di acquisizione e di valutazione della prova (artt. 18-77). Evidente ap-
pare l’opzione a favore della prova legale. Con una scelta che sarà fatta propria pochi
anni dopo anche dall’Ordonnance di Villers-Cotterêts, la Carolina privilegia la confes-
sione e la prova testimoniale, mentre mostra una profonda diffidenza per le presunzioni
e le prove indiziarie, sulle quali vieta espressamente di fondare la condanna (art. 22).
La piena prova risulta dalla confessione o dal detto di «due o tre testimoni buoni e cre-
dibili» (artt. 65, 67). In difetto di piena prova si ricorre alla tortura.
5.2.3. Tortura e ‘indizio sufficiente’
La complessa regolamentazione degli indizi richiesti per procedere all’esame sotto tor-
tura (il testo usa l’espressione redliche anzeygung: ‘sufficiente indizio’) e delle condi-
zioni per ratificare la confessione in tal modo ottenuta costituisce la parte della Caroli-
na nella quale sono maggiormente evidenti gli effetti della recezione della dottrina ita-
liana. Presupposti di tale regolamentazione sono il divieto di tortura in assenza di «in-
2
dizi sufficienti» (art. 20), e il principio secondo cui gli indizi richiesti per la tortura non
3
sono comunque sufficienti per la condanna (art. 22). Gli indizi necessari alla tortura
sono ricompresi in accurati elenchi non tassativi e suscettibili di estensione analogica
(art. 24). Vengono in primo luogo considerati gli indizi remoti, tra i quali sono enume-
rati la reputazione, le abitudini, le amicizie, il fatto di trovarsi sulla strada che conduce
al luogo del delitto, il fatto di presentare abiti o altri caratteri simili a quelli presentati
2 La garanzia prevista dall’art. 20 della Carolina è di carattere generale: in assenza dei richiesti
presupposti indiziari la confessione sotto tortura e la conseguente condanna sono nulle, e in questo caso la
violazione delle regole costituisce giusta causa di risarcimento per l’imputato.
3 Ad esempio, una sola testimonianza a carico costituisce una «semiprova» o «mezza prova», sufficiente
per la tortura ma non per la condanna (artt. 23 e 30).
44