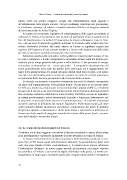Page 42 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 42
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
soluto, volto con sempre maggiore energia alla centralizzazione degli apparati e
all’affermazione della propria autorità. Tali provvedimenti contribuiscono potentemen-
te a delineare i princìpi, gli istituti e i caratteri distintivi della fase di maggiore maturità
del processo penale di Antico Regime.
Al centro del movimento legislativo di statualizzazione delle regole procedurali si
collocano la Francia e la Germania. Qui un ruolo di particolare rilievo è assunto, tra la
fine del Quattrocento e la metà del Cinquecento, da alcune ordonnances regie in Fran-
cia, e da una serie di interventi legislativi culminati in Germania nella celeberrima Con-
stitutio Criminalis Carolina. Ma anche altrove in Europa si registrano segnali non
equivoci dell’esistenza di una comune tendenza a fissare nella legislazione dello Stato
gli esiti di esperienze e pratiche processuali ormai consolidate.
Attraverso queste scelte normative, nelle legislazioni rinascimentali europee si vie-
ne così a configurare a livello continentale la medesima virtuale unità del modulo pro-
cedurale già da tempo presente nella prassi e nella dottrina. A tale processo di omoge-
neizzazione corrispondono sia – come accennato – il progressivo accentramento dei
poteri giurisdizionali nelle mani dei giudici delle corti regie, sia il ragguardevole svi-
luppo della giurisprudenza dei grandi tribunali centrali degli Stati europei, sorti nume-
rosi nel corso del Quattrocento e avviati ad assumere un ruolo di assoluta preminenza
nel panorama delle strutture giurisprudenziali del tardo diritto comune.
Le vicende ora riassunte comportano ovviamente una serie di rilevanti conseguenze
sul piano dell’amministrazione della giustizia penale. Da una parte ne accentuano infat-
ti l’efficacia repressiva, migliorando la funzionalità degli apparati pubblici, e rendendo
più agevole il ricorso a una serie di strumenti tecnici talora finemente elaborati (si pensi
alle complesse costruzioni dottrinali in tema di indizi). Dall’altra, cercano di inquadrare
in schemi predeterminati i poteri discrezionali di giudici e funzionari, intervenendo sul-
la situazione di pressoché totale assenza di regolamentazione e di controllo instauratasi
nel primo periodo di diffusione del modulo inquisitorio. Nello stesso tempo, gli inter-
venti normativi statuali favoriscono un’ulteriore compressione dei poteri d’iniziativa
del privato, tendono a disconoscere i diritti della difesa e sanzionano la definitiva af-
fermazione degli aspetti di maggiore iniquità del sistema della prova legale, a comin-
ciare dall’ordinario ricorso alla tortura.
4.2. Le origini del modello inquisitorio francese
Cerchiamo ora di dare maggiore concretezza al discorso prendendo in esame alcune situa-
zioni paradigmatiche e spostando innanzitutto la nostra attenzione sul regno di Francia.
In Francia le trasformazioni in senso inquisitorio delle strutture procedurali si svol-
gono fino al XV secolo quasi esclusivamente attraverso la giurisprudenza delle corti
reali, che viene fissata a livello consuetudinario e, in misura invero minore, attraverso
l’elaborazione dottrinale. In questo primo periodo gli interventi regi hanno carattere
eccezionale e si limitano a sanzionare le regole affermatesi nella prassi. Le norme con-
suetudinarie, le leggi regie e le pratiche giudiziarie vengono talora riunite in farraginose
32