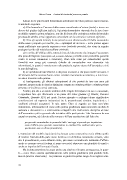Page 38 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 38
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
Alcune tra le più rilevanti discordanze sottolineate da Claro possono essere riassun-
te nel modo seguente.
a) Alla domanda se l’accusa debba essere considerata un’azione (actio) o invece un
dovere del giudice (officium iudicis), il giurista alessandrino risponde che de iure è sen-
za dubbio esatta la prima soluzione, ma che di fronte alla evoluzione subita dal modello
processuale sembra ormai opportuno concordare con la contraria e comune opinione.
b) Circa gli aspetti formali, lo ius prescrive con chiarezza che il libello accusatorio
debba essere proposto per iscritto, ma – «quidquid sit de iure» – nella pratica appare
ormai sufficiente una querela espressa a voce (verbalis querela), che viene in seguito
posta per iscritto dal notaio/cancelliere criminale.
c) In ordine all’obbligo della sottoscrizione del documento che impegna l’accusatore
alla pena del taglione (inscriptio ad poenam talionis, prevista come preventiva garanzia
contro le accuse calunniose e temerarie), Claro nota come per consuetudine questa
formalità non venga più osservata («hodie de consuetudine non observatur ista
solemnitas»), in quanto è venuta meno nella pratica la ragione stessa dell’inscriptio, e cioè
la pena del taglione.
d) Le questioni de iure relative a chi possa accusare, a chi possa essere accusato, e
all’idoneità dell’accusatore hanno ormai carattere meramente accademico, e non trova-
no alcun riscontro nella pratica.
e) Analogamente, gli ulteriori adempimenti di rito previsti de iure non sono più
rispettati, mentre anche la classica distinzione romana tra crimina publica e crimina privata
presenta un’incidenza ormai attenuata.
Peraltro, più che a un esame analitico delle singole discrepanze tra ius e consuetudo,
è opportuno fare qui riferimento a un passo del Liber Quintus (§ Finalis, Practica
Criminalis, Quaestio XIV) nel quale l’autore riprende e sviluppa talune significative
considerazioni sul rapporto instauratosi tra le preponderanti strutture inquisitorie e i
vacillanti principi accusatori. In tale passo Claro ci segnala un fatto senz’altro
sintomatico, informandoci di come nella pratica giudiziaria assai raramente sia dato di
assistere a discussioni o a controversie collegabili alla tradizionale disciplina de iure
dell’accusatio o più in generale alle iniziative delle parti private. Tale fenomeno ha una
causa ben precisa, ed è dovuto alla comune e diffusa accettazione del fatto che
per generale consuetudine in pressoché tutti i casi oggi si procede per inquisizione
ossia d’ufficio («ex generali consuetudine in omnibus fere casibus hodie per in-
quisitionem, seu ex officio proceditur»).
L’estensione del modello inquisitorio ha dunque avuto come primo ovvio effetto quello
di rendere l’attività della parte meno incisiva e in definitiva meramente virtuale, visto
che il procedimento, come abbiamo visto, può essere normalmente instaurato d’ufficio
anche se nessuno accusi («etiam si nemo accuset») attraverso una pluralità di canali e
anche su impulso dell’avvocato fiscale.
Ma la detta estensione ha avuto anche una ulteriore rilevante conseguenza, in quan-
to – come Claro osserva quotidianamente nella pratica giudiziaria («ut quotidie vide-
mus in practica observari») – ha permesso ai giudici in primo luogo di accogliere sem-
28