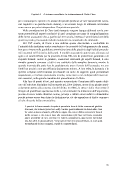Page 39 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 39
Capitolo 3 – Il sistema consolidato: la testimonianza di Giulio Claro
pre e comunque le querele e le accuse dei privati (anche se de iure mancanti dei neces-
sari requisiti o in qualche modo viziate), e in secondo luogo di utilizzare tali istanze
come mezzo per poter intraprendere l’inquisizione speciale.
Nelle considerazioni di Claro testé riassunte vengono dunque delineati con la con-
sueta puntualità gli aspetti conclusivi di quel complesso processo di marginalizzazione
delle forme accusatorie che, a partire dal XIII secolo, interessa l’amministrazione della
giustizia penale, provocando radicali mutamenti sia concettuali che strutturali.
Nel XVI secolo, di fronte a una dottrina spesso disorientata e combattuta tra
l’autorità della tradizione anche accademica e la necessità dell’adeguamento alla prassi,
ben poco rimane nella quotidiana amministrazione della giustizia degli istituti procedu-
rali incentrati sull’iniziativa delle parti. Il modello accusatorio autorizzava chiunque ad
agire e si caratterizzava per la presenza di una fitta rete di prescrizioni garantiste e di
requisiti formali: cadute le garanzie, considerati irrilevanti gli aspetti formali, il solo
rimedio generale concesso a tutti è ora costituito dalla semplice denuncia, mentre la
querela riservata alla parte lesa ha gradatamente preso il posto dell’accusatio, ma con
limiti ben precisi e con una efficacia decisamente minore. A loro volta, la denuncia e la
querela svolgono nell’economia processuale un ruolo di supporto quali praeambula
inquisitionis, e risultano pienamente inserite, come meri e non indispensabili meccani-
smi accessori, nella grande macchina del procedimento d’ufficio.
Alla luce di questi rilievi, può apparire sorprendente l’ampiezza dello spazio dedi-
cato all’articolata disciplina dell’accusatio nel Liber Quintus, opera di un giurista parti-
colarmente attento alla concreta vita del diritto. In effetti, lo stesso Giulio Claro sente il
bisogno di giustificare questa sua scelta e, nel concludere la trattazione dell’argomento,
precisa di avere voluto illustrare norme, principi e istituti ormai caduti in desuetudine
perché potesse essere ben chiara la distinzione tra ciò che appartiene al diritto comune e
ciò che discende dalla consuetudine:
E questa è la forma secondo la quale si procede in base al diritto comune nel giudizio
di accusa, che tuttavia (come ben vedi) è caduto quasi totalmente in desuetudine. Non
ho voluto tuttavia ometterlo, affinché tu sappia che cosa si debba osservare in base al
diritto comune e che cosa in base alla consuetudine («Et haec est forma, secundum
quam proceditur de iure communi in iudicio accusationis, quae tamen (ut vides)
tota fere abiit in desuetudinem. Volui tamen illam non praetermittere, ut scias quid
servandum sit de iure communi, et quid de consuetudine»).
29