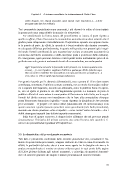Page 37 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 37
Capitolo 3 – Il sistema consolidato: la testimonianza di Giulio Claro
contra aliquem, nisi aliquid praecedat, quod aperiat viam inquisitioni, […] aliter
processus esset ipso iure nullus»).
Tra i praeambula inquisitionis sopra enumerati, i più rilevanti in ordine al tema trattato
in questa sede sono senza dubbio la querela e la denuntiatio.
Pur sottolineando la diversa natura del procedimento su istanza di parte rispetto a
quello ex officio, Claro rileva come la consuetudine ammetta senza alcun ostacolo che il
giudice possa intraprendere immediatamente l’inquisizione speciale non appena ricevu-
ta la querela di parte. In effetti, la querela si è bensì sostituita alla classica accusatio,
ma da questa differisce profondamente, in quanto nella pratica non presenta più i requi-
siti anche formali considerati de iure necessari per avviare un processo accusatorio (a
cominciare dal libello accusatorio e dalla inscriptio posta a protezione dalla calunnia).
Di conseguenza, ogni questione relativa a tali requisiti risulta normalmente priva di si-
gnificato non solo grazie ai mutamenti dovuti alla consuetudine, ma anche perché
oggi l’inquisizione concorre in pressoché tutti i processi con la stessa querela ossia
accusa […] e così il giudice supplisce d’ufficio a qualunque difetto («hodie inqui-
sitio concurrit in omnibus fere processibus cum ipsa querela sive accusatione […]
et sic iudex ex officio supplet quoscunque defectus»).
Per quanto riguarda poi la denuncia (denuntiatio), essa a parere di Claro deve essere
considerata, nonostante l’opinione comune contraria, non un modo di procedere ordina-
rio e separato dall’inquisitio, ma solo uno strumento, come la pubblica fama e la quere-
la, atto ad aprire al giudice la via dell’inquisizione speciale. La denuncia da parte di
pubblici ufficiali di varia natura è ormai pratica diffusissima in tutta Italia, ma le regole
formali del diritto comune non impediscono che in base alla consuetudine chiunque
possa liberamente denunciare al giudice – senza rispettare la disciplina de iure prevista
per l’accusatio – le proprie o le altrui offese («iniuriam sibi vel alteri factam»). E in
queste occasioni i giudici possono procedere assai agevolmente («de facili procedunt»),
secondo una «bona practica» volta a impedire – come recita l’antico brocardo – che i
delitti rimangano impuniti («ne delicta impunita remaneant»).
Sulla base di quanto osservato, è dunque lecito affermare che nel processo penale
cinquecentesco l’iniziativa del privato conserva una certa rilevanza solo quando si ri-
solva in un praeambulum legitimum all’inquisizione.
3.5. La desuetudine del procedimento accusatorio
Tale dato è pienamente confermato dalle accurate quaestiones che, nonostante il tra-
monto di questa forma processuale, vengono elaborate da Claro in tema di accusatio. In
effetti, la profondità del solco che si è man mano aperto tra la disciplina de iure e la
pratica consuetudinaria si mostra con piena evidenza quasi in ogni punto delle pagine
del Liber Quintus dedicate agli schemi accusatori, e coinvolge sia questioni sistemati-
che e di carattere generale che singole e minute prescrizioni di carattere formale.
27