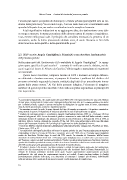Page 26 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 26
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
l’accusa può essere presentata da chiunque) e crimina privata (perseguibili solo su ini-
2
ziativa della parte lesa). In secondo luogo, l’accusa tende non solo a trasformarsi nella
querela della parte lesa, ma anche a confondersi con la semplice denuncia.
A tali significative indicazioni se ne aggiungono altre, che testimoniano come talo-
ra venga a mancare la stessa percezione della diversa natura di accusa e inquisizione.
Così, mentre nella prassi cade il principio che considera necessaria la presenza di un
accusatore, anche la forma processuale adottata cessa di avere rilevanza ai fini della
3
determinazione della qualità e della quantità della pena.
2.3. Il XV secolo: Angelo Gambiglioni e l’inquisitio come struttura fondamentale
del processo penale
4
Nella prima metà del Quattrocento il De maleficiis di Angelo Gambiglioni – la «mag-
5
giore opera specifica di quel secolo» – consente di verificare come la dottrina, nei de-
6
cenni seguiti al lavoro di Alberto da Gandino, abbia reagito e partecipato ai mutamenti
ora accennati.
Questo nuovo tractatus, composto intorno al 1438 e destinato ad ampia diffusio-
ne editoriale e duraturo successo, si propone di discutere i problemi del diritto e del
processo criminale seguendo la traccia costituita dagli atti di un procedimento imma-
7
ginato dallo stesso autore. Ai fini della presente indagine, l’elemento di maggiore
interesse di questo ipotetico modello è dato dalla sua piena rispondenza ai principi del
rito inquisitorio.
2 La procedura inquisitoria, che negli statuti dei secoli XIII-XIV è di regola prevista per una serie limitata
di reati gravi, in progresso di tempo viene impiegata nella prassi non solo per i crimina pubblica, ma anche
per i crimina privata, e grazie a questa evoluzione la distinzione in oggetto cessa di avere, quantomeno
sotto il profilo processuale, contorni e significati precisi.
3
La massima secondo la quale la pena dipende dal tipo di impulso processuale è di matrice canonistica.
Essa prevede in genere l’irrogazione di una pena più mite in caso di procedimento ex officio.
4
Giurista al contempo pratico e accademico, Angelo Gambiglioni (Arezzo 1400 ca. - Bologna 1461) si
laurea a Bologna nel 1422. Per un decennio è giudice e assessore in varie città dell’Italia centrale, e avvia
un’intensa attività di consulente che prosegue per tutta la vita. Professore a Bologna dal 1431 al 1445, si
stabilisce infine a Ferrara, chiamato da Leonello d’Este. Nel 1452 come ambasciatore della sua città natale
ottiene dall’imperatore Federico III il privilegio di legittimazione dello Studium di Arezzo.
5
Domenico Maffei, Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento, Frankfurt am Main,
Klostermann, 1979, p. 43.
6 La tradizionale storiografia giuridica collocava in questo periodo sia una Practica iudiciaria in materiis
criminalibus attribuita a Iacopo di Belviso e composta prima del 1308, che un Tractatus super maleficiis
scritto da Bonifacio Vitalini dopo la metà del XIV secolo. Le ricerche di Domenico Maffei hanno
dimostrato la inattendibilità di tali dati: il Tractatus super maleficiis nasce in realtà entro i primissimi anni
del Trecento a opera non dell’inesistente Bonifacio Vitalini ma del giudice mantovano Bonifacio Antelmi;
quanto alla Practica pseudo-belvisiana, si tratta di un lavoro formatosi nella Francia meridionale alla metà
del XIV secolo grazie alla giustapposizione di materiali di epoche diverse.
7 Il trattato è diviso in 86 sezioni. La prima contiene i verbali del caso pratico ipotizzato da Gambiglioni,
relativi sia alla ricostruzione dei fatti («Inquisitio») che alla decisione finale («Forma Sententiae»). Le
restanti 85 formano altrettante rubriche nelle quali l’autore approfondisce analiticamente gli spunti
problematici che egli stesso ha copiosamente inserito nei verbali. Questa struttura tradisce le finalità
prevalentemente pratiche dell’opera, e ne determina al contempo i caratteri più rilevanti, individuabili
nella prevalenza delle questioni di natura processuale e nella mancanza di completezza.
16