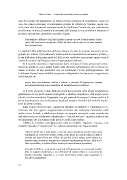Page 24 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 24
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
caso di accedere all’inquisizione (e talora a forme sommarie di inquisizione, come nel
caso del crimen notorium). Accuratamente studiati da Alberto da Gandino, questi con-
cetti erano stati largamente impiegati anche da Guillaume Durand che, pur continuando
ad affermare in linea di massima la necessità dell’accusa, aveva nondimeno sostenuto il
principio tipicamente canonistico secondo il quale
l’inquisizione differisce dagli altri giudizi in quanto in essa la fama assume la fun-
zione dell’accusatore («inquisitio differt ab aliis iudiciis quia in ea fama habetur
loco accusatoris»).
Lo standard della pubblica fama definisce dunque il grado di sospetto necessario al ma-
gistrato per iniziare il procedimento anche senza la necessità di un accusatore privato, e
la sua diffusione dalla prima metà del XIII secolo costituisce una potente spinta verso la
‘normalizzazione’ dell’inquisizione come procedura ordinaria.
b) Il secondo elemento è rappresentato dallo sviluppo di forme processuali sostan-
zialmente parallele, come quella basato sulla denuncia (denuntiatio), che in buona so-
stanza si risolve in uno strumento atto ad autorizzare l’avvio dell’inquisizione. Già
Guillaume Durand aveva stabilito un preciso collegamento tra denuncia e inquisizione,
sottolineando che
spesso dopo una denuncia relativa a crimini si procede all’inquisizione («saepe
post denunciationem super criminibus ad inquisitionem proceditur»).
c) Il terzo elemento è dato dalla pur sporadica presenza nella stessa compilazione
giustinianea di non pochi spunti ricollegabili a strutture inquisitorie, dall’ampio venta-
glio di casi che ammettono l’inquisitio a un più generale favore per la forma scritta e la
prova documentaria, che costituiranno altrettanti caratteri distintivi del modello inquisi-
torio di diritto comune.
Sullo scorcio del Duecento, i giuristi si sforzano di difendere e confermare la co-
struzione che loro appare maggiormente conforme alla tradizione romanistica nella
quale si sono formati, e stabiliscono dunque un rapporto tra regola e caso speciale che
essi stessi sono poi condannati a disattendere – bon gré mal gré – quando prendono atto
dei mutamenti che si svolgono nella pratica e nella consuetudine.
Alberto da Gandino contrappone più volte un modello ‘regolare’, l’accusa, a un
modello ‘speciale’, l’inquisizione. Lo vediamo ad esempio nei seguenti passi:
Tuttavia quello che è stato detto, e cioè che senza accusatore nessuno può essere
condannato né il processo andare avanti, viene meno nei casi speciali nei quali si
procede per inquisizione per officio del giudice («Hoc tamen, quod dictum est,
neminem sine accusatore damnari nec criminis cognitionem procedere, fallit in ca-
sibus specialibus, in quibus officio iudicis per inquisitionem proceditur).
Secondo il diritto […] canonico si procede all’inquisizione se si sono già manife-
state le seguenti condizioni, e non altrimenti di regola («Iure […] canonico de
quolibet maleficio inquiritur […] si iam interveniant omnia, quae sequuntur, et
non aliter regulariter»).
14