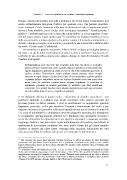Page 21 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 21
Capitolo 1 – Interest reipublicae ne crimina remaneant impunita
Dunque, Alberto da Gandino non esita a dichiarare che al suo tempo l’inquisizione può
essere ordinariamente intrapresa d’ufficio per qualsiasi reato. Una parziale giustifica-
zione dottrinale di tale fenomeno sulla base di alcuni passi della compilazione giusti-
11
nianea è forse possibile, ma in fin dei conti non appare necessaria. Semplicemente, i
giudici e i podestà agiscono così in base alla consuetudine: lo aveva segnalato il mae-
12
stro del nostro autore, Guido da Suzzara; lo conferma ora lo stesso Gandino, in forza
della sua personale e lunga esperienza di giudice: questo è il metodo comunemente os-
servato e dunque percepito come normale, nonostante la sua contrarietà ai dettami dello
ius civile. Ciò che conta è l’effettività.
Un’avvertenza è peraltro necessaria. Altro è infatti svolgere un’indagine generica
sul reato e su chi lo abbia eventualmente commesso, altro è condurre l’inquisizione nei
confronti di una specifica persona (che assume dunque le vesti di imputato). Precisa
Gandino al proposito:
Sull’inquisizione però che deve fare il giudice nota bene che rileva se il giudice
penale conduca l’inquisizione contro qualche singola e specifica e nominata persona
oppure inquisisca in generale in ordine al reato su chi abbia commesso quel reato. E
qualora conduca l’inquisizione contro qualche singola persona, allora bisogna
osservare le regole fissate nel Liber Extra, titolo De accusationibus, capitolo Qualiter
et quando («Super inquisitione autem per iudicem faciendam bene nota quod refert
utrum iudex de maleficio inquirat contra aliquam singularem et specialem et
nominatam personam an inquirat generaliter de maleficio quis illud maleficium
commiserit. Et si quidem inquirat contra aliquem singularem personam tunc servandus
est ordo traditus Extra De accu. c. Qualiter et quando»).
Il De maleficiis delinea in questo modo – riferendosi al modello canonistico – una
partizione destinata a costituire uno snodo essenziale nello schema generale del
processo penale di diritto comune, e cioè la suddivisione tra inquisizione generale
(inquisitio generalis, svolta per accertare l’avvenuta commissione del reato e per
acquisire informazioni generiche sullo stesso quando ancora non si conosce il colpevole
e si cerca di individuarlo) e inquisizione speciale (inquisitio specialis, che presuppone
lo svolgimento dell’inquisizione generale ed è finalizzata alla assunzione di indizi e
prove che dimostrino la colpevolezza di uno specifico imputato). L’inquisitio specialis,
soggiunge Gandino, non può essere svolta arbitrariamente dal giudice, ma richiede la
sussistenza di determinate condizioni che sono quelle fissate dal già citato capitolo
Qualiter et quando del Liber Extra: consegna della citazione, indicazione dei capi
d’accusa, possibilità di replicare alle accuse e di contestare le testimonianze.
11 Nel contesto del passo testé riportato Gandino inserisce in effetti un elenco di sette frammenti
giustinianei che potrebbero fornire argomenti atti a giustificare le attitudini dei giudici e dei podestà
(«quod videtur posse facere per haec iura»), attitudini che peraltro, come abbiamo visto, si fondano sulla
sola consuetudine.
12 L’allusione è forse alle Supleciones a Cod., 4, 2, pr. e a Cod., 9, 42, 2, in sostanza corsi tenuti da Guido
da Suzzara in forma di quaestiones. Guido da Suzzara (…1247-1293) è tra i giuristi del maturo Duecento
maggiormente interessati al rapporto tra teoria e prassi. Chiamato come professore di ius civile a Modena
dal 1260 e a Bologna dal 1266, nel biennio 1268-1270 è a Napoli, professore e consigliere del re Roberto
d’Angiò. Dal 1270 insegna a Reggio Emilia e dal 1278 di nuovo a Bologna.
11