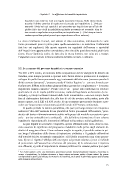Page 25 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 25
Capitolo 2 – La diffusione del modello inquisitorio
Secondo lo ius civile nei reati è di regola necessaria l’accusa. Nello stesso modo,
secondo il diritto canonico di regola non si procede per inquisizione […] Ma per
entrambi i diritti nei casi speciali si può procedere per inquisizione per ufficio del
giudice («De iure civili in maleficiis regulariter necessaria est accusatio. Item de
iure canonico regulariter non proceditur per inquisitionem […] Sed utroque iure in
casibus specialibus potest procedi per inquisitionem officio iudicis»).
Lo stesso Guillaume Durand, così attento al dato canonistico, introducendo le varie
forme processuali pone in primo piano quella accusatoria e ne sottolinea l’ordinarietà
(«et hoc est regulare»). Ma questo rapporto tra regolarità dell’accusa e specialità
dell’inquisizione appare subito contraddetto, oltre che dalla quotidiana realtà giudiziaria
(come rileva Gandino), anche da fatto che la stessa dottrina non esita poi a trattare
l’inquisitio come metodo in buona sostanza del tutto normale e ordinario.
2.2. Le premesse del processo inquisitorio romano-canonico
Tra XIII e XIV secolo, al momento della composizione del De maleficiis di Alberto da
Gandino, sono dunque presenti e operanti tutti i fattori idonei a promuovere il compiuto
sviluppo di quella forma processuale oggi variamente definita come ‘processo penale di
diritto comune (europeo)’, ‘processo penale d’Antico Regime’ o – con una formula par-
ticolarmente diffusa nella cultura giuspenalistica germanica e anglosassone – ‘processo
inquisitorio romano-canonico’. Prende così il via – grazie alla confluenza tra strutture
giudiziarie in via di rapida pubblicizzazione, scelte del legislatore ecclesiastico (e mu-
nicipale), e principi ordinatori desunti dalle fonti romanistiche – una non sempre facile
fase di elaborazione dottrinale che, alla luce di ciò che avviene nella pratica, porta alla
messa a punto, tra il XIII e il XVI secolo, di uno strumento processuale destinato a pre-
valere per lungo tempo nel panorama giurisdizionale dell’Europa continentale.
In questo periodo la scienza penalistica, che pure per lungo tempo non rinuncia a
1
sostenere l’idea dell’esistenza di una pluralità di forme processuali differenziate, pren-
de atto del deciso ridimensionamento subito nella prassi dal modello accusatorio e pro-
cede – pur tra contraddizioni e ambiguità – alla definitiva sistemazione di uno schema
inquisitorio rispondente alle innovazioni diffusesi nella pratica e nella legislazione.
La pari dignità tra accusatio e inquisitio, spesso affermata sulla carta, viene in con-
creto svuotata di significato dal progressivo indebolirsi nella prima degli elementi di-
stintivi di maggiore rilievo. Come vedremo meglio in seguito, è possibile notare in pri-
mo luogo l’abbandono delle forme di ispirazione civilistica e il graduale affievolirsi
dell’autorità del rito accusatorio romanistico: a) il libello accusatorio non viene presen-
tato; b) non si rispetta l’obbligo della inscriptio ad poenam talionis; c) non si richiede
di perseverare nell’accusa fino al termine del processo; d) la calunnia non è repressa
con efficacia; e) perde d’importanza la classica partizione tra crimina publica (nei quali
1 Pur indirizzandosi verso una sistematica processuale penale fondamentalmente bipolare, incentrata su
accusa e inquisizione, la dottrina riconosce a lungo natura autonoma anche a forme minori (in genere
corrispondenti a quelle già indicate da Durand e da Gandino), tra le quali la più vitale appare quella basata
sulla denuncia (denuntiatio).
15