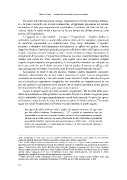Page 20 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 20
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
Da questo articolato panorama emerge, segnatamente a livello di sviluppo dottrina-
le e in piena concordia con le fonti romanistiche, un’apparente prevalenza del sistema
accusatorio. Il dato però maggiormente significativo è costituito dal fatto che tale pre-
valenza risulta in realtà messa a dura prova da una sempre più diffusa presenza, nella
pratica, dell’inquisizione.
Al rapporto tra i due modelli – l’accusa e l’inquisizione – Gandino dedica in
particolare i paragrafi terzo e quarto della settima rubrica del De maleficiis, «Quomodo
de maleficiis cognoscatuur per inquisitionem». Dopo avere individuato il carattere
peculiare e distintivo dell’inquisizione nell’iniziativa ex officio del giudice, Gandino
dapprima ribadisce il principio generale, già posto nella prima rubrica dell’opera, secondo
il quale il giudice non può indagare su tutti i crimini poiché, se manca l’accusatore, lo
svolgimento del processo e l’imposizione della pena non sono consentiti («super quolibet
crimine non potest nec debet inquirere, quia legitur quod sine accusatore criminis
cognitio et pene impositio non procedunt»). Vi sono peraltro numerosi casi nei quali sia
per lo ius civile che per il diritto canonico è dato al giudice di operare ex officio, e tali
9
casi, già segnalati nel trattare l’accusatio, sono di nuovo scrupolosamente elencati.
Al momento di tirare le fila del discorso, Gandino sembra finalmente concludere
ribadendo ulteriormente che de iure civili è necessaria di regola l’accusa («regulariter
necessaria est accusatio»), e che nello stesso modo secondo il diritto canonico di regola
non si procede per inquisizione («regulariter non proceditur per inquisitionem») se non
nei casi specifici e già illustrati («sed utroque iure in casibus specialibus potest procedi
per inquisitionem officio iudicis, quos casus notavi supra»).
Questo è appunto quanto dovrebbe accadere «regulariter». Ma la realtà della quoti-
diana amministrazione della giustizia è ormai assai diversa. Lo attesta il seguente passo
del De maleficiis, che segue immediatamente quelli testé riassunti. Si tratta del «passo
10
più famoso e citato di tutta la storia del processo penale di diritto comune», in quanto
segna uno snodo fondamentale nell’intera vicenda riassunta in queste pagine:
Ma oggi nell’ambito dello ius civile i giudici dei podestà conoscono di ogni reato
per loro ufficio mediante l’inquisizione […] E i giudici si comportano così per
consuetudine, come nota il maestro Guido e come ho visto comunemente osservare,
sebbene sia in realtà contro lo ius civile («Sed hodie de iure civili iudices potestatum
de quolibet maleficio cognoscunt per inquisitionem ex officio suo […] Et ita servant
iudices de consuetudine, ut notat dominus Guido, e ut vidi communiter observari,
quamvis sit contra ius civile»).
quale l’inquisitio è vista come uno dei quattro fondamentali meccanismi processuali di accertamento
criminale previsti dalle fonti romane (accusatio, denunciatio, delatio, inquisitio).
9 Per lo ius civile l’elenco ricomprende una ventina di casi, ed è ripreso molto probabilmente dallo
Speculum iudiciale di Guillaume Durand. Per il diritto canonico le condizioni che consentono di avviare ex
officio l’inquisizione sono quelle stabilite dalla decretale Qualiter et quando del Liber Extra. Notiamo
altresì, sempre in tema di inquisitio, come Gandino affermi in più occasioni, citando un testo del re Pipino
ripreso dalla Lombarda (2.25.15) e interpretato invero assai estensivamente, che secondo il diritto
longobardo è possibile ricorrere all’inquisizione per ogni reato.
10 Mario Sbriccoli, «Vidi communiter observari». L’emersione di un ordine penale pubblico nelle città
italiane del secolo XIII, «Quaderni Fiorentini», 27 (1998), pp. 231-268, in particolare p. 238.
10