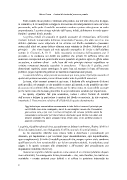Page 18 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 18
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
Testo redatto da un pratico e destinato alla pratica, ma tutt’altro che privo di digni-
tà scientifica, il De maleficiis sviluppa la discussione dei temi penalistici entro un’ottica
processuale, nella quale il modello accusatorio sembra a prima vista giocare un ruolo
preponderante. Le prime cinque rubriche dell’opera, infatti, definiscono in modo appro-
fondito i caratteri di tale metodo.
La prima, «Quid sit accusatio et quando accusator sit necessarius», utilizzando
risalenti formule romanistiche definisce innanzitutto l’accusa, che altro non è se non
deferire qualcuno come colpevole di un crimine nel libello accusatorio («accusare
autem nihil aliud est, quam deferre aliquem reum criminis in libello». Stabilisce poi il
principio – che viene basato sul noto episodio evangelico di Cristo e dell’adultera
narrato in Giovanni, 8, 10-11 – della necessaria sussistenza dell’accusatore per il
processo e la condanna nei delitti sia pubblici che privati. Si sofferma infine sui
numerosi casi speciali nei quali risulta invece possibile al giudice agire ex officio senza
accusatore, e sostiene altresì – sulla base del noto principio interest reipublicae ne
crimina remaneant impunita segnalato in precedenza – l’idea che il giudice, posti
determinati requisiti, possa costringere la parte lesa ad accusare in base all’interesse
pubblico («quia expedit rei publicae ne maleficia remaneant sine pena»).
La seconda rubrica, «Qui possunt accusare et qui non», pone il principio secondo il
quale tutti possono accusare, ma ne discute anche tutte le possibili eccezioni.
La terza, «Qui accusari possunt et qui non», è dedicata allo scioglimento di alcuni
nodi specifici; ad esempio: se sia possibile accusare gli assenti; se sia possibile una dop-
pia accusa nei confronti della stessa persona per lo stesso reato; se sia possibile accusare
per lo stesso reato chi sia stato già assolto in un procedimento condotto per inquisizione.
La quarta, «Qualiter fiat ipsa accusatio», indica i criteri formali di validità
dell’accusa e delinea in particolare i caratteri del libello accusatorio. In tale contesto,
importante è l’osservazione relativa all’effettività di questo adempimento:
Oggi tuttavia per consuetudine comunemente in tutta Italia si osserva il principio per
cui il libello non viene consegnato, ma si fa una semplice accusa che l’accusatore
giura essere vera, e poi così si scrive nel registro del comune («Hodie autem de
consuetudine communiter per totam Italiam observatur, quod libellus non datur, sed
simplex accusatio fit, quam accusator iurat, veram esse, et sic scribitur postea in
quaterno communis»).
La quinta, «Qualiter advocati circa accusationem se debeant continere», illustra i diritti e i
doveri dei patrocinatori, non disdegnando di offrire una serie di consigli pratici.
Le tre successive rubriche sono invece volte a descrivere i procedimenti per
denuncia, per inquisizione e per eccezione («per denuntiationem», «per inquisitionem»,
«per exceptionem»). Si tratta di modelli processuali che, sempre a prima vista, sembrano
qualificarsi per la loro occasionalità o per la loro complementarietà. In particolare, assai
esiguo è lo spazio concesso alla denuntiatio e all’exceptio (sul procedimento per
inquisizione torneremo tra breve).
Denunciare significa deferire qualcuno come autore di un crimine («deferre aliquem
reum criminis»). La conseguente forma processuale – che, nota Gandino, ha matrici ca-
nonistiche – mostra contorni poco definiti e si colloca in posizione intermedia tra
8