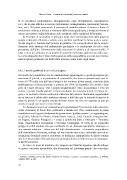Page 102 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 102
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
tà di esecuzione (impiccagione, strangolamento, rogo, decapitazione, squartamento,
ecc.) che di pene afflittive accessorie (arrotamento, attanagliamento, mutilazioni, bastona-
ture, ecc.). Sul piano processuale il principio di umanità inibisce il ricorso a forme di
coercizione violenta, a iniziare ovviamente dalla tortura giudiziaria, e incide sul ricorso al
carcere preventivo e sulla definizione delle modalità e delle condizioni dello stesso.
d) Principio di razionalità. Il principio esige che l’amministrazione della giustizia
penale si dimostri efficiente e celere, senza peraltro sacrificare le forme poste a garan-
zia dei singoli e i fondamentali principi di giustizia. Ciò comporta da un lato la sempli-
ficazione delle strutture dell’ordinamento giudiziario e lo snellimento dei riti e delle
procedure, dall’altro l’eliminazione delle situazioni di arbitrio e di discrezionalità. Il
tutto si deve poi collocare in un quadro di controllo dell’esatta applicazione delle rego-
le, nel presupposto che il buon funzionamento della cosa pubblica non può non riverbe-
rarsi sul pieno godimento dei diritti della persona e sulla tutela degli stessi.
10.2. I nuovi significati di un’antica disputa
Gli autori che prenderemo ora in considerazione appartengono a quella prestigiosa ge-
nerazione di giuristi, e in particolare di criminalisti, che inizia a operare negli anni at-
torno al 1770 sulla scia dell’atto fondativo del moderno diritto penale, costituito dalla
pubblicazione in forma anonima, a Livorno nel 1764, del trattatello Dei delitti e delle
1
pene di Cesare Beccaria. Veri e propri «traghettatori» verso la modernità e l’età dei
codici, i giuristi ‘postbeccariani’ si fanno mediatori tra il sistema penale di Antico Re-
gime e le razionali e laiche costruzioni elaborate dal pensiero illuminista, segnalandosi
da un lato per il rifiuto delle posizioni estreme e dall’altro per la volontà di inserire la
giustizia penale in un quadro strutturale bensì nuovo ma che non respinga in toto gli
assetti nei quali essi stessi si sono formati.
Le Animadversiones ad criminalem jurisprudentiam (Osservazioni sulla giurispru-
denza criminale) di Paolo Risi, pubblicate a Milano nel 1766, costituiscono la prima
manifestazione di questa fondamentale generazione ‘postbeccariana’, cui appartengono,
tra gli altri, Alberto De Simoni, Filippo Maria Renazzi, Luigi Cremani, Francesco Ma-
rio Pagano, Gaetano Filangieri e – ormai a cavallo tra Sette e Ottocento – Tommaso
Nani, Giandomenico Romagnosi e Giovanni Carmignani. Si tratta di un composito
gruppo di solidi studiosi che, pur oscillando tra un attenuato astrattismo ideologico e
una marcata adesione – talora non del tutto disinteressata – al concreto pragmatismo
dell’Assolutismo riformista, realizza nel suo insieme una seria e articolata opera di si-
stemazione dottrinale intesa a rielaborare la tradizione criminalistica di diritto comune
alla luce dei prodotti della speculazione giusnaturalistica e delle innovazioni propugna-
te dall’Illuminismo.
Le idee e le prese di posizione che vengono qui illustrate appaiono quindi collega-
te, spesso con nesso inscindibile, alle discussioni sul ‘problema penale’ che coinvolgo-
1 Adriano Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, 2, Milano,
Giuffrè, 2005, p. 221.
92