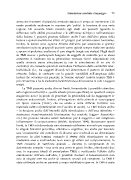Page 91 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 91
Stimolazione cerebrale e linguaggio 73
senza che fenomeni di plasticità cerebrale abbiano il tempo di intervenire. Ciò
rende possibile analizzare in maniera più ‘pulita’ la funzione di una certa
regione. Un secondo limite inerente agli studi sui pazienti riguarda le
differenze nelle abilità pre-morbose e le differenze nel tipo e nell’estensione
della lesione. I pazienti possono differire molto l’uno dall’altro prima della
lesione e quindi analizzarne effetti di ‘gruppo’ può talvolta essere fuorviante.
Inoltre, le lesioni sono ognuna diversa dall’altra per estensione e gravità:
conclusioni certe su gruppi di pazienti vanno quindi sempre tratte con cautela
e spesso si preferisce analizzare il caso singolo (single case studies). Negli studi
di TMS invece i partecipanti fungono da soggetti di controllo per se stessi
attraverso il confronto tra la prestazione ottenuta ‘sotto’ stimolazione con
quella ottenuta senza stimolazione (o con la stimolazione di un sito di
controllo): ciò consente quindi di controllare l’influenza della variabilità inter-
individuale (i.e., tra soggetti diversi) nel determinare il pattern di risultati
ottenuto. Infine, in contrasto con la grande variabilità nell’ampiezza delle
lesioni che occorrono nei pazienti, la ‘lesione virtuale’ indotta tramite TMS è
più circoscritta e ha la medesima localizzazione e dimensione in tutti i soggetti
testati.
La TMS presenta anche diversi limiti. Innanzitutto è possibile stimolare
solo regioni corticali (i.e., quelle situate più in superficie), in quanto il campo
magnetico non è in grado di penetrare in profondità tali da raggiungere le
strutture sottocorticali. Inoltre, all’erogazione dello stimolo si accompagna
un tipico rumore (‘click’) che ne rende a volte difficile l’utilizzo con
materiale uditivo (interferendo con l’ascolto di suoni). La TMS induce anche
– in funzione anche dell’intensità della stimolazione e dell’area stimolata –
sensazioni somatosensoriali (contrazione dei muscoli, leggero formicolio,
etc.) che possono talvolta essere fastidiose per il soggetto e nel complesso
influenzarne il comportamento (Walsh, Rushwort 1999). Nonostante questi
limiti, la TMS si è dimostrata uno strumento utilissimo non solo per mappare
le singole funzioni percettive, attentive o cognitive, ma anche per tracciare
una ‘cronometria’ del contributo di diverse aree cerebrali in un determinato
processo. In altri termini, variando il timing della stimolazione su una
medesima area e studiandone man mano gli effetti sul comportamento, la
TMS consente di verificare quando – durante lo svolgimento di un
determinato compito – una certa area entra in gioco. Inoltre, stimolando due
aree in sequenza (studi di paired-pulses TMS) e verificando l’effetto della
stimolazione dell’una sull’altra, è possibile studiare il funzionamento non
solo di singole aree ma anche di network neurali più complessi. La TMS è
stata utilizzata anche su pazienti a scopo riabilitativo (per es. la TMS è usata