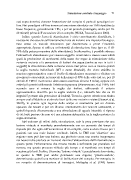Page 89 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 89
Stimolazione cerebrale e linguaggio 71
casi sopra descritti, durante l’esecuzione del compito si parla di paradigmi on-
line. Nei paradigmi off-line invece un’area viene stimolata con TMS ripetitiva (a
basse frequenze, generalmente 1 Hz, e per un periodo prolungato, anche per 10-
20 minuti) prima dell’esecuzione di un compito (Walsh, Pascual-Leone 2003).
Infine, quando l’area di stimolazione è stata correttamente identificata, è
necessario che essa sia sufficientemente forte da indurre una risposta fisiologica.
Non esiste un metodo sistematico per determinare a priori l’intensità
appropriata. Spesso si utilizza un’intensità di stimolazione fissa (per es. il 65-
70% della potenza massima dello stimolatore). In alternativa, è possibile stimare
l’intensità di stimolazione per ciascun soggetto ricorrendo a misure osservabili
quali la produzione di movimenti della mano che segue la stimolazione della
corteccia motoria o la percezione di fosfeni che segue (anche se non in tutti i
soggetti) la stimolazione della corteccia visiva. Nel primo caso si misura quindi
la soglia motoria individuale (MT o motor threshold), che viene stabilita in
maniera approssimativa come il livello di stimolazione necessario a elicitare un
movimento osservabile nei muscoli della mano il 50% delle volte (ad es., per 10
stimoli di TMS il movimento deve essere osservato almeno 5 volte), oppure con
criteri più precisi utilizzando l’elettromiogramma (Wassermann et al. 1999). Nel
secondo caso si misura la soglia dei fosfeni, utilizzando il criterio
approssimativo descritto per la soglia motoria (i.e., intensità tale che su 10
impulsi 5 portano alla percezione di fosfeni). Tuttavia, questo criterio non risulta
sempre così affidabile se si stimola fuori dalle aree motorie e visive (Stewart et al.
2001b), in quanto ogni regione dello scalpo si caratterizza per un diverso
spessore dei tessuti e per un diverso orientamento dei neuroni sottostanti, e
quindi risponde diversamente a una stimolazione di uguale intensità. A riprova
di ciò, basti pensare che non vi è una relazione sistematica tra la soglia motoria e la
soglia dei fosfeni.
Nel valutare gli effetti della stimolazione, vale la pena precisare che una
lesione virtuale si manifesta prevalentemente con un aumento dei tempi di
risposta più che agire sull’accuratezza di un compito, come avviene invece per i
pazienti con una reale lesione cerebrale. Infatti, la TMS non ‘disattiva’ una
regione come può fare una lesione, ma piuttosto causa una scarica temporanea
nei neuroni che produce un ‘rumore’ durante l’elaborazione dell’informazione; a
questo punto l’informazione che rimane intatta è sufficiente per prevalere sul
rumore, ma questo processo richiede più tempo e si manifesta con tempi di
reazione più lenti. Inoltre, il termine ‘lesione virtuale’ è parzialmente fuorviante,
in quanto la TMS può anche potenziare una regione, ‘preattivandola’,
determinando quindi una reazione di facilitazione del compito. Per esempio, in
un compito di denominazione di immagini, Mottaghy et al. (1999) hanno