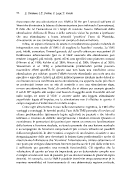Page 90 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 90
72 Z. Cattaneo, J.T. Devlin, C. Lega, T. Vecchi
riscontrato che una stimolazione con rTMS a 20 Hz per 2 secondi sull’area di
Wernicke diminuisce la latenza di denominazione (non inficiando l’accuratezza).
Il fatto che né l’accuratezza né i tempi di reazione fossero influenzati dalla
stimolazione dell’area di Broca o della corteccia visiva ha portato a ipotizzare
che una stimolazione a bassa intensità ‘preattiva’ l’area di Wernicke,
dimostrando un suo coinvolgimento nel compito di denominazione.
Infine, un aspetto rilevante da tenere in considerazione quando si decide di
intraprendere uno studio di TMS è di scegliere la ‘baseline’ corretta. La TMS
può, infatti, aumentare l’arousal generale del cervello attraverso meccanismi di
facilitazione intersensoriale (per es. il ‘click’ associato alla stimolazione può
rendere i soggetti più veloci); questi effetti non specifici sono piuttosto comuni
(Flitman et al. 1998; Kohler et al. 2004; Nixon et al. 2004; Shapiro et al. 2001;
Wasserman et al. 1999) e potenzialmente problematici poiché possono
nascondere effetti specifici. In questo caso non basta una condizione senza
stimolazione per valutare quanto l’effetto trovato stimolando una certa area sia
specifico o aspecifico. Infatti, gli effetti inibitori possono risultare molto deboli se
confrontati con una condizione senza stimolazione, ma apparire molto più chiari
se confrontati invece con un sito di controllo o con una stimolazione sham,
ovvero una stimolazione ‘finta’, di controllo, che si ottiene per esempio girando
il coil di 90° rispetto allo scalpo: così facendo il soggetto sente il contatto del coil
sullo scalpo, ne sente il ‘click’ e avverte anche una leggera stimolazione
superficiale legata all’impulso, ma la stimolazione non è effettiva in quanto il
campo magnetico è indirizzato fuori dallo scalpo.
Come ogni altra tecnica in uso nelle neuroscienze cognitive, la TMS offre
vantaggi e svantaggi. In termini pratici, l’uso della TMS permette di ovviare ad
alcune problematiche tipicamente legate agli studi su pazienti e che talvolta
inficiano o rendono di difficile interpretazione i risultati ottenuti. Quando si
considerano le prestazioni dei pazienti per trarne un nesso tra localizzazione
della lesione e funzione studiata, va tenuto presente che una lesione cerebrale
è accompagnata da fenomeni compensatori più o meno robusti resi possibili
dalla neuroplasticità. In altre termini, a seguito di una lesione, si assiste a una
riorganizzazione delle aree circostanti la lesione (aree perilesionali) o anche di
aree lontane dalla lesione che ‘vicariano’ l’area lesionata, ovvero subentrano al
suo posto per svolgere determinate funzioni (anche se ciò il più delle volte non
è sufficiente per garantire una normale funzionalità). Ciò significa che la
valutazione di quanto un’area sia importante per un determinato compito non
è sempre accurata nel caso di pazienti per via dei meccanismi di plasticità sopra
descritti. Al contrario, con la TMS è possibile interferire temporaneamente (e in
maniera reversibile) col funzionamento di una determinata regione corticale,