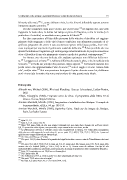Page 27 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 27
La filosofia come terapia, autotrasformazione e stile di vita in Seneca 15
126
bilmente alla meta. E, come abbiamo visto, la vita diverrà tollerabile appena avremo
127
intrapreso questo cammino.
128
Ciò che veramente conta non è vivere, ma vivere bene; ciò implica che, una volta
raggiunta la meta etica, la durata nel tempo è priva di rilevanza, e che la morte (e in
129
particolare il suicidio) va accettata come garanzia di libertà.
Per dare espressione all’idea della pienezza della vita che s’identifica col raggiun-
gimento della saggezza e della virtù Seneca conferisce una sfumatura personale al si-
gnificato pregnante che vivere e vita assumevano spesso nella lingua parlata, dove veni-
130
vano impiegati per esprimere il godimento materiale della vita. È ben possibile che con
questa formulazione linguistica egli contrapponga intenzionalmente la propria concezione
131
etica e filosofica di una vita pienamente vissuta a quella dei gaudenti contemporanei.
Per Seneca una vita non dedicata allo studium sapientiae non differisce dalla mor-
133
132
te. La saggezza è un’arte: e sebbene differisca da tutte le altre, e sia in realtà la sola
134
135
vera arte, si fonda sui princìpi che possono essere appresi. Certamente saranno ben
136
pochi coloro che apprenderanno l’arte di vivere; solo il saggio è il vero ‘artista della
137
vita’, artifex vitae. Noi non possiamo lusingarci di poter divenire come lui; dobbiamo
però vivere tutta la nostra vita senza mai perdere di vista questa meta ideale.
Bibliografia
Albrecht von, Michael (2004), Wort und Wandlung. Senecas Lebenskunst, Leiden-Boston,
Brill.
Allegri, Giuseppina (2004), Progresso verso la virtus. Il programma della lettera 87 di
Seneca, Cesena, Stilgraf Editrice.
Armisen-Marchetti, Mireille (1986), Imagination et méditation chez Sénèque: l’exemple de
la praemeditatio, «REL», 64, pp. 185-195.
Armisen-Marchetti, Mirelle (1989), Sapientiae facies. Étude sur les images de Sénèque,
Paris, Les Belles Lettres.
126
Epist. 71,1-2.
127
Epist. 6,1; cfr. sopra, nota 38.
128
Epist. 70,4 quae (vita), ut scis, non semper retinenda est; non enim vivere bonum est, sed bene vivere;
101,15 quam bene vivas referre, non quam diu; saepe autem in hoc esse bene, ne diu.
129
Le affermazioni nell’uno e nell’altro senso sono innumerevoli in Seneca. Per l’idea della compiutezza
della vita una volta raggiunta la meta etica cfr. per es. epist. 32,3; 40,10; 77,4; 93,2-3; 101,8; etc. I passi sul
suicidio sono troppo numerosi per elencarli qui.
130 Cfr. Setaioli (1988, pp. 273-284).
131 Cfr. epist. 123,10, dove Seneca fa la parodia del significato dato a vivere e vita da Trimalchione e dai suoi
pari.
132 Cfr. epist. 55,3; 60,4; 77,18; 93,2-4; tranq. an. 5,5; cfr. anche epist. 82,3 (sopra, nota 114). Per il topos della
mortua vita cfr. Setaioli (2000, p. 314 n. 218). In de ot. 7,1 Seneca cerca di unificare i tre tipi di vita
tradizionali (njʐǙǜ ǠǓǕʎǎǙǗǙǜ, ǠǓǕǦǝǙǠǙǜ, ǠǓǕǦǞǓǖǙǜ) sotto il comune denominatore della contemplatio filosofica.
133 Epist. 29,3 sapientia ars est; 90,44 ars est bonum fieri.
134 Cfr. l’intera epist. 88.
135 Cfr. Bellincioni (1979, p. 230) su epist. 95,7 haec (sapientia) ars vitae est.
136 Cfr. epist. 77,18 vivere vis: scis enim?
137
Vit. beat. 8,3; epist. 90,27; 95,7. Cfr. Kuen (1994, 136).