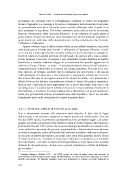Page 144 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 144
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
processuale che raccoglie tutte le verbalizzazioni realizzate su ordine del magistrato
durante l’inquisitio. La consegna è di regola accompagnata dalla fissazione di un termi-
ne, generalmente assai breve (da pochi giorni a poche settimane) entro il quale il reo
deve presentare le sue difese. Tali difese consistono nella realizzazione di un secondo
fascicolo documentale, detto ‘processo difensivo’, la cui redazione di regola spetta al
patrocinatore. Il fascicolo difensivo viene consegnato nei termini prescritti al giudice, il
quale decide poi sulla base della documentazione scritta contenuta nei due fascicoli,
l’offensivo e il difensivo.
Appare evidente come la difesa tecnica abbia, in una siffatta situazione, ben poche
carte da giocare, e in tempi assai ristretti. E nella pratica il ‘processo difensivo’ si risol-
ve in una più o meno approfondita memoria scritta, per lo più articolata in capitula in-
farciti di citazioni di autorità dottrinali, di testi legali e di opinioni più o meno comuni.
In tale memoria l’avvocato, ricorrendo a una consolidata tecnica dialettica di matrice
bartolistica e facendo volentieri sfoggio di un’erudizione che peraltro appare non di
rado fuor di luogo, illustra – se esiste – il materiale probatorio favorevole all’imputato e
immancabilmente solleva tutte le eccezioni che ritenga opportune. Nel caso di rei con-
fessi egli può, ad esempio, sostenere che la confessione sia stata estorta, o che non sia
sufficientemente circostanziata, o che mancassero i presupposti richiesti per il ricorso
alla tortura. Nel caso di rei negativi cerca di far rilevare le nullità, i vizi processuali, i
difetti di forma che abbiano eventualmente inficiato il lavoro del giudice inquisitore.
Nell’un caso e nell’altro la netta impressione che si ricava dall’esame delle fonti è che
tali allegazioni, e in particolare le raffiche di eccezioni in esse contenute, fossero per lo
più inefficaci, e servissero in buona sostanza solo a dimostrare, con la loro stessa pre-
senza, che gli essenziali principi processuali erano stati rispettati, e che il reo era stato
formalmente posto nella condizione di svolgere le proprie difese.
A.4. La «rivoluzione nell’arte di difendere gli accusati»
Non è sicuramente estraneo alla situazione testé descritta il fatto che la figura
dell’avvocato o del causidico impegnato in materia penale non sembri godere, fino alla
fine del XVIII secolo, di particolare considerazione tra le professioni legali e, di conse-
guenza, nel quadro più generale delle strutture cetuali di Antico Regime. Ma è proprio a
partire dalla fine del XVIII secolo che le nuove ideologie penalistiche e la stessa rivolu-
zione codicistica innescata dal pensiero giusnaturalista e illuminista iniziano ad avere
profonde conseguenze anche sull’attività dell’avvocato penalista e sulla sua collocazio-
ne non solo in ambito processuale, ma anche nella scala delle gerarchie sociali. Siamo
di fronte al primo tra i momenti di transizione richiamati in precedenza, un momento
che è all’origine – per citare le parole di Giuseppe Marocco, il più famoso tra i penalisti
milanesi di età napoleonica – di una vera e propria «rivoluzione nell’arte di difendere
1
gli accusati».
1 Giuseppe Marocco (Milano 1773 - ivi 1829) svolge un ruolo di primo piano nel processo di
rinnovamento dell’avvocatura penale legato all’introduzione, nei codici del primo Ottocento, del nuovo
modello processuale. Di famiglia borghese, dopo aver frequentato il collegio dei padri Somaschi di
134