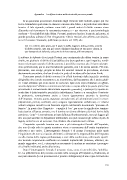Page 143 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 143
Appendice – La difesa tecnica nella storia del processo penale
In un panorama processuale dominato dagli elementi testé indicati, appare più che
lecito domandarsi quali siano le chances concesse alla difesa, e in particolare alla difesa
tecnica. A tale riguardo, notiamo come tutti i grandi autori di diritto comune siano
d’accordo nel riconoscere la necessaria presenza e – per ricorrere a una terminologia
moderna – l’inviolabilità della difesa. Per tutti, possiamo lasciare la parola, sul punto, al
grande penalista udinese di fine Cinquecento Tiberio Deciani, che afferma con decisio-
ne nel Tractatus Criminalis, pubblicato postumo nel 1590, che
non vi è crimine tanto grave, per il quale si debba negare la difesa, poiché, essendo
di diritto naturale, essa non può essere eliminata («nullum est tam grave crimen, in
quo deneganda sit defensio, quia cum sit de iure naturae, tolli non potest»).
E sebbene la defensio di cui parla Deciani non corrisponda alla difesa tecnica in senso
stretto, ma piuttosto al diritto di (auto)difesa che deve spettare a ogni imputato, nondi-
meno nel processo penale di diritto comune è possibile osservare che il ricorso al patro-
cinio professionale, pur se non formalmente garantito, non è di norma assente. Più sem-
plicemente, esso svolge, proprio in forza dei caratteri elencati in precedenza, un ruolo
decisamente secondario, che ben di rado è in grado di incidere sulla decisione finale.
Il processo penale di diritto comune è in effetti dominato dalla inquisitio condotta
dal giudice che è anche accusatore o, se si preferisce, dall’accusatore che è anche giudi-
ce. Come abbiamo già avuto modo di osservare, egli avvia il procedimento ex officio,
accerta dapprima l’effettiva commissione del reato o corpus delicti (e questa prima fase
processuale è comunemente denominata inquisitio generalis), e passa poi (e questa se-
conda fase è detta inquisitio specialis) a individuarne l’autore e a raccogliere il materia-
le probatorio, eventualmente anche a favore (quantomeno secondo la dottrina)
dell’imputato. Durante questa inquisitio specialis tutti gli adempimenti posti in essere
(deposizioni, perizie, confronti, ecc.) vengono rigorosamente verbalizzati, e i relativi
verbali vengono raccolti in un fascicolo segreto solitamente denominato ‘processo of-
fensivo’. In questa fase l’imputato – o meglio il ‘reo’, per usare la significativa termino-
logia tecnica all’epoca corrente, ove il termine reo (come abbiamo già visto) deriva dalla
parola res, ‘cosa’ – è normalmente privato della sua libertà personale, non può leggere gli
atti, non può ascoltare le deposizioni testimoniali, non può conoscere gli indizi, né può, di
regola, conferire con un avvocato. Può chiedere che si sentano testi a difesa.
L’inquisitio specialis termina con uno o più interrogatori formali dell’imputato,
che non di rado solo in questa occasione viene a conoscenza dell’esatta imputazione
sollevata a suo carico. L’interrogatorio formale è di norma l’occasione nella quale
l’inquisitore che non sia riuscito altrimenti a dimostrare la responsabilità dell’imputato
va alla ricerca della regina probationum, e cioè della confessione, utilizzando specifi-
che tecniche ampiamente codificate nei manuali inquisitoriali (minacce, allusioni, do-
mande suggestive, ecc.), e ricorrendo se necessario (e qualora ne sussistano i presuppo-
sti a livello indiziario) anche alla tortura.
Dopo l’interrogatorio formale il processo viene, come si era soliti dire, ‘pubblica-
to’. La pubblicazione del processo consiste nella consegna all’imputato e, finalmente, al
suo patrocinatore (la cui presenza non è peraltro obbligatoria) di una copia del fascicolo
133