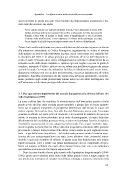Page 151 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 151
Appendice – La difesa tecnica nella storia del processo penale
meriti del testo in parola non solo l’aver limitato «la degenerazione accademica o tea-
trale delle discussioni», ma anche
l’aver colpito alcune non lodevoli abitudini forensi, l’aver disboscato la selva delle
nullità, proficua delizia dei cacciatori di cavilli, e disseccato la fonte dei gravami
formali, l’aver tolto di mezzo le facili cause d’annullamento a cui si prestava
l’istituto delle notificazioni, l’aver soppresso il divieto della reformatio in peius,
l’aver tarpato le ali alla logorrea imperversante non di rado nei dibattimenti.
Talune fra le scelte sottolineate con piena soddisfazione dal ministro segnano un ritorno
alla situazione antecedente al Codice Romagnosi, segnatamente in ordine al sistema
delle nullità e al divieto della reformatio in peius, che si collocavano tra i capisaldi del-
la disciplina del 1807. E lo stesso principio già affermato all’inizio dell’Ottocento se-
condo il quale l’imputato deve essere obbligatoriamente assistito in dibattimento da un
avvocato scelto dallo stesso imputato o, qualora egli non voglia o non sia in grado di
scegliere, assegnato d’ufficio, subisce ora un vulnus non indifferente grazie alla norma
secondo la quale l’avvocato che abbandoni la difesa in dibattimento può essere imme-
diatamente sostituito non con un altro professionista, ma con un appartenente all’ordine
giudiziario. Superfluo rammentare che tale norma viene all’epoca apertamente e unanime-
mente giudicata dagli ordini professionali italiani lesiva sia dei diritti dell’imputato che
dell’autonomia e dello stesso prestigio della classe forense.
A.7. Dal «garantismo inquisitorio» del secondo dopoguerra alla riforma dell’art. 111
della Costituzione (1999)
La terza e ultima fase che scandisce la vicenda storica dell’avvocatura penale in Italia
prende avvio alla fine della seconda guerra mondiale e giunge fino al deciso (quanto-
meno sur le papier) mutamento di prospettive determinato dall’entrata in vigore del
codice vigente. Se la prima fase, fino alla fine del Settecento, aveva visto l’avvocato
penalista confinato nel ruolo privo di mordente e di incisività di redattore di memorie
scritte, la seconda lo aveva proiettato, in un ruolo da protagonista, al centro della fase
dibattimentale del cosiddetto processo misto, e aveva nel contempo favorita la rapida e
irresistibile ascesa sociale di una categoria professionale fino a quel momento larga-
mente negletta. La terza fase ha infine visto una progressiva estensione delle garanzie
processuali e dunque della presenza della difesa tecnica anche in quel segmento istrut-
torio – e per definizione inquisitorio – del tradizionale processo misto di matrice napo-
leonica che per centocinquant’anni era stato, come abbiamo visto, pressoché imper-
meabile a ogni serio tentativo di riforma. A questa terza fase dedicheremo solo alcune
rapide notazioni, volte a offrire una prima informazione circa la complessità dei pro-
blemi sul tappeto, problemi che negli ultimi decenni hanno dato vita a una letteratura
specialistica cresciuta con ritmi talora esponenziali.
Dopo le prime timide riforme già presenti nella legislazione luogotenenziale (1944-
1946), questo nuovo periodo nella storia della difesa penale è stato a lungo segnato da
una produzione normativa di carattere novellistico collegata a numerosi interventi della
141