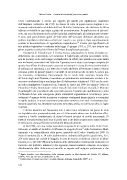Page 152 - Ettore Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 152
Ettore Dezza – Lezioni di storia del processo penale
Corte Costituzionale e avente per oggetto gli aspetti più rigidamente inquisitori
dell’impianto codicistico del 1930. La chiave di volta di questa nuova stagione è ov-
viamente individuabile nel dettato dell’art. 24 della Costituzione, che definisce la difesa
«diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». In applicazione di tale arti-
colo, ma con riferimento anche ad altri principi costituzionali, gli adempimenti istrutto-
ri sono stati parzialmente aperti all’intervento dell’avvocato difensore attraverso una
politica legislativa informata a criteri per i quali a suo tempo è stata opportunamente
10
coniata la denominazione di «garantismo inquisitorio». L’esito più significativo di
tale politica legislativa è costituito dalla legge 19 giugno 1955, n. 517, che delinea una
prima organica e articolata riforma dell’intera disciplina processuale.
Il tentativo di ‘liberalizzare’ il Codice Rocco, adeguandone le norme al dettato co-
stituzionale ma conservando nel contempo il tradizionale schema processuale misto,
non ha peraltro avuto esiti sempre soddisfacenti. In effetti, tale tentativo ha avuto limiti
non irrilevanti, consistenti nel fatto che l’apertura non è stata a suo tempo completa (in
quanto ha sofferto di talune gravi eccezioni ad esempio in tema di prova testimoniale e
di colloqui col detenuto), e nel fatto che il ruolo attribuito all’avvocato è stato in buona
sostanza quello di garante passivo e notarile di un’attività svolta da altri. A questo pri-
mo momento, sviluppatosi faticosamente ma in modo tutto sommato lineare fino
all’inizio degli anni Settanta, è succeduto un quindicennio estremamente confuso e in-
coerente conclusosi (dopo una lunga fase di elaborazione iniziata nel 1962 con la nomi-
na della commissione Carnelutti) con l’entrata in vigore nel 1989 del vigente Codice di
Procedura Penale, denominato Codice Vassalli dal nome Giuliano Vassalli, il Ministro
Guardasigilli che sovraintese alla sua realizzazione. Durante tale quindicennio e sotto
l’influenza di ben note emergenze (dalla criminalità organizzata al terrorismo) i prov-
vedimenti d’urgenza dettati in risposta a esigenze contingenti hanno iniziato a susseguirsi
in rapida cadenza. In questo panorama tempestoso numerosi sono stati i revirements deci-
samente autoritari, ma altrettanto numerose sono state anche, se così si può dire, le fughe
in avanti.
L’ultimo decennio del Novecento non è stato meno tormentato dal punto di vista
sia legislativo che giurisprudenziale, ma si è felicemente chiuso con la definitiva affer-
mazione a livello costituzionale di alcuni rilevanti principi di civiltà processuale. Si
tratta di vicende svoltesi nell’arco di pochi anni e che dalla cronaca sono ormai transita-
te nella storia. Sarà sufficiente rammentarle telegraficamente.
a) Nel 1992, con una svolta inquisitoria segnata da tre sentenze della Corte Costi-
11
tuzionale, si assiste al tentativo di affossare la «regola d’oro» della formazione dibat-
timentale e in contraddittorio della prova, introdotta dal Codice Vassalli del 1989. Si
tratta di sentenze (la n. 24 sulla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria; la n.
254 sulla lettura dei verbali d’indagine in caso di ricorso al diritto al silenzio in dibat-
timento; la n. 255 sull’efficacia probatoria delle dichiarazioni testimoniali contenute nel
fascicolo del pubblico ministero) che appaiono massicciamente orientate al recupero
dibattimentale delle dichiarazioni raccolte in segreto nell’indagine preliminare e che
10 Ennio Amodio, voce Motivazione della sentenza penale, in Enciclopedia del Diritto, 27, Milano,
Giuffrè, 1977, pp. 181-257, in particolare p. 182.
11 2
Paolo Ferrua, Il ‘giusto processo’, seconda edizione, Bologna, Zanichelli, 2007 , p. 1.
142