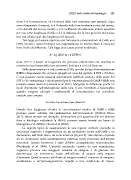Page 163 - Stefano Rastelli (a cura di), La ricerca sperimentale sul linguaggio: acquisizione, uso, perdita, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 163
fNIRS nello studio del linguaggio 145
dove A è l’attenuazione, I è l’intensità della luce trasmessa (per esempio dopo
aver oltrepassato il mezzo), Io è l’intensità della luce incidente prima del mezzo,
c è la densità del mezzo, mentre α è il coefficiente di estinzione molare specifico
per una certa lunghezza d’onda e d è la distanza che la luce percorre nel mezzo
(nei casi ideali è pari alla lunghezza del mezzo).
Tale legge può essere applicata per valutare le concentrazioni di O2Hb and
HHb, tuttavia i tessuti biologici non rappresentano un mezzo chiaro a causa del
forte livello di diffusione. Tale legge deve essere perciò modificata:
A=-log (I/Io)=(α·c·d·DPF)+G
dove DPF è il fattore di lunghezza del percorso differenziale che descrive la
traiettoria non lineare della luce nei tessuti biologici e G è la diffusione.
Nelle strumentazioni a onda continua (CW), uno dei tre tipi di strumentazione
fNIRS a disposizione che verranno spiegati nel corso del capitolo, il DPF e il fattore
G non possono essere misurati direttamente (sebbene esistano delle stime del
DPF) e di conseguenza i valori assoluti per le concentrazioni di O2HB e HHb non
possono essere ottenuti (Gervain et al. 2011). Malgrado la diffusione giochi un
ruolo dominante nell’attenuazione della luce, il suo contributo è trascurabile
quando vengono calcolati i cambiamenti di concentrazione nei cromofori,
essendo essa costante:
A=((cossi*αossi)+(cdeossi*αdeossi))+d+DPF
Usando due lunghezze d’onda, le concentrazioni relative di O2HB e HHb
possono essere calcolate dal cambiamento nell’attenuazione (Pellicer, Bravo
2011). Senza entrare nel dettaglio, informazioni più approfondite sui principi
fisici e fisiologici sottostanti la fNIRS, possono essere trovate nei lavori di
Strangman et al. (2002) e Ghosh et al. (2012).
La risposta tipica di ossigenazione in una regione corticale coinvolta in
un’attività cognitiva è rappresentata da un incremento locale nell’O2Hb e un
decremento nell’HHb due o tre volte inferiore (Figura 2). Tale risultato dipende
da un incremento nella vasodilatazione arteriosa locale provocato dall’attività
neuronale. Questo fenomeno è stato definito accoppiamento neurovascolare
(Steinbrink et al. 2006). L’attività neuronale causata da una stimolazione
cognitiva, provoca una maggiore richiesta di ossigeno e di glucosio che
determinano un incremento locale dell’afflusso di sangue nella regione
d’interesse. Quest’aumento del flusso di sangue eccede il consumo di ossigeno,
conducendo a un’iperossigenazione rispetto a una condizione di riposo.